«C’era un sortilegio nella notte silvestre che incantava tutti i miei sensi. In me l’essere intimo rispondeva senza che lo volessi, senza che neppure lo sapessi al richiamo notturno di tutto ciò che era vegetale, vitale, arcano».1
È in una stretta e scomoda striscia di terra dell’estremo ponente ligure che, sul finire dell’Ottocento, nascono maestosi giardini punteggiati di ville e Château. In questi luoghi spazzati dal mistral, che vi giunge attutito dai picchi rossastri dell’Esterel, si realizza il «sogno babilonese»2 alimentato da ricchi inglesi che scoprirono, all’epoca, la potenza trasformatrice e, in certi casi guaritrice, del giardino. Il primo di questi inglesi a stabilirsi sulle coste che, solo più tardi, prenderanno il nome di Côte d’Azur e Italian Riviera, fu Thomas Bennet, il ginecologo della Regina Vittoria. Affetto da tubercolosi e condannato a pochi anni di vita, Bennet cercava, nel clima mite della costa Mediterranea, un rimedio alle sue sofferenze. Stabilitosi a Mentone, nel 1865 acquista una serie di terreni con annessa torre saracena a Grimaldi, un piccolo paese arroccato sulle alture al confine tra Italia e Francia. È qui che Bennet farà restaurare la torre, che futuri proprietari trasformeranno nello Château Grimaldi, e creerà uno splendido giardino di acclimatazione eternamente bagnato dal sole e con le radici nell’acqua. Qualche anno dopo, a pochi chilometri da Grimaldi, a La Mortola, un uomo d’affari inglese amico di Bennet, Thomas Hanbury, si prodigò anche lui nella creazione di un giardino che nulla aveva da invidiare a quelli babilonesi della regina Semiramide. Se oggi la villa di Bennet, dopo una serie di peripezie e cambi di proprietà è stata trasformata in appartamenti privati e del giardino sopravvivono solo alcune specie, i Giardini Hanbury sono invece ancora visitabili e mantengono intatto il loro sogno vegetale a picco sul grande blu.

È in questo paesaggio per certi aspetti ancora dantesco,3 impraticabile, nel quale le montagne premono i terrazzamenti e i paesi verso il mare, dove piante grasse strisciano al suolo, i fiori esplodono, i rampicanti inondano i pergolati e colorano, tutto l’anno, la costa, che nasce, nel 1905, Marise Ferro. Questi luoghi, nei quali la scrittrice trascorrerà l’infanzia e l’adolescenza, rimarranno sempre per lei un punto di partenza e di ritorno, una costante che si ritrova in diverse sue opere e che, a ben guardare, anticipa di molto, nell’attenzione e nel modo, tanti scrittori che verranno dopo di lei, attenti a far vivere il paesaggio nelle loro opere, ma che avranno ben più fortuna di lei nel non essere, ad un certo punto, dimenticati. Perché, purtroppo, la storia di Marise Ferro – la quale in vita ebbe una sua notorietà – è la storia dell’oblio di una scrittrice quasi inevitabilmente scivolata nel cono d’ombra delle tante scrittrici che non riescono, una volta scomparse, a garantirsi un posto nel canone sempre troppo maschile del quale ancora disponiamo. E così, dopo una prima edizione, i suoi romanzi non vengono più ristampati, anche se di lei resta, nel catalogo Einaudi, la traduzione italiana, la prima, di Splendori e miserie delle cortigiane, una parte della Comédie humaine di Honoré de Balzac. Marise Ferro, infatti, non fu solo scrittrice, ma anche una prolifica traduttrice di romanzi dal francese e, in misura minore, dall’inglese. Fu tra le prime in Italia a tradurre Simenon e poi Mérimée, Mauriac e moltissimi altri autori di epoche diverse e, l’autore che forse più di tutti le fu caro, Balzac. L’influenza della cultura e della letteratura francese in lei fu molto forte, tanto che il nome che sceglierà per firmare romanzi e articoli è Marise, da pronunciarsi à la française con la “e” muta (il suo nome anagrafico era Maria Luisa). Oltre alle precoci lettura dei grandi classici d’oltralpe, «io già contaminata, piena di Baudelaire»,4 dirà più tardi assimilando sempre l’amore per la letteratura a una vera e propria malattia, ragioni biografiche e territoriali influenzeranno questa sua predilezione per la cultura francese. La nonna materna, infatti, era originaria di Tolone, e i luoghi nei quali Ferro trascorre l’infanzia e l’adolescenza, quelli dell’estremo Ponente ligure, sono territori di confine da sempre contaminati con l’autre côté della frontiera.
Narratrice, traduttrice, giornalista, l’opera di Ferro è ampia e, se oggi possiamo, almeno in parte, nuovamente riscoprirla, ridarle quel posto che le spetta nella storia della letteratura e leggerla alla luce dell’epoca che stiamo attraversando, servendocene, senza tuttavia abusare di un’autrice «moderna del secolo trascorso»,5 è grazie al prezioso lavoro intrapreso e condotto da Francesca Sensini, scrittrice e docente universitaria all’Université Côte d’Azur. Da qualche anno, infatti, Sensini sta curando la riedizione delle opere ferriane corredandole di approfondite introduzioni (alle quali rimandiamo per una visione completa dell’opera della scrittrice ventimigliese) che sono uno strumento indispensabile per orientarsi nella riscoperta di una voce del secolo scorso, ma, per molti aspetti, attuale e necessaria. La ripubblicazione inizia nel 2020 con una raccolta di articoli giornalistici ritrovati presso la Fondazione Carlo e Marise Bo di Urbino e pubblicati nel volume Una donna moderna del secolo trascorso. Marise Ferro giornalista a cura di Francesca Sensini e Federica Lorenzi. L’attività giornalistica di Ferro si estende nell’arco di trent’anni e si concentra su tematiche quali la letteratura, il ruolo della donna nella società e il paesaggio. Nello stesso anno esce per l’editore Gammarò La guerra è stupida (l’unica opera ristampata nel 2005, originariamente pubblicata nel 1949), un romanzo di testimonianza scritto durante la guerra, dal 1935 al 1945. Una narrazione dall’impianto originale nella quale la testimonianze autobiografiche si alterna a brevi racconti che paiono storie raccolte tra le macerie di una nazione svilita. La guerra raccontata da Ferro è insulsa, «stupida» appunto, e questa caratteristica viene rimarcato spesso nel libro sotto forma di pamphlet o di invettiva, senza che, tuttavia, la narrazione si trasformi mai veramente in fatto di cronaca, ma rimanga in bilico sul filo spinato della realtà e del sogno. «Io sono una romanziera, io divago, racconto, sogno; e seguo il filo del sogno e della finzione, questa parente stretta del sogno, li indago, li valuto, li espongo. Sono una pessima ricostruttrice della realtà».6 Ferro racconta la guerra e, attraverso una lingua precisa e attenta, arriva ad esporla in tutta la sua nudità e insensatezza: «non lo spiego, se lo spiegassi sarei una cattiva romanziera, espongo soltanto, cerco di dare delle sensazioni, di esprimere i caratteri e di rendere evidenti i fatti».7
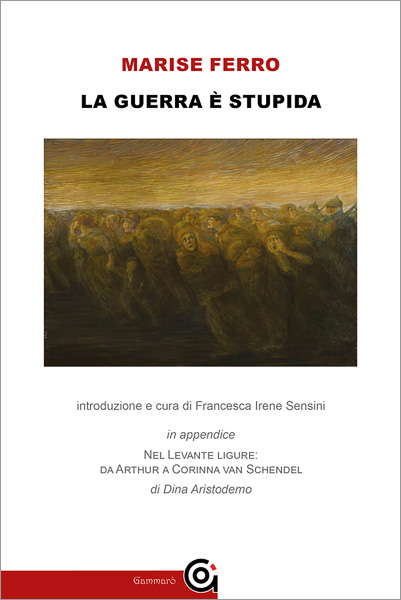
Nel 2021 esce poi la raccolta di racconti Le Romantiche, pubblicata una prima volta nel 1958, nella quale la scrittrice narra la storia di dodici donne vissute tra Settecento e Ottocento, che incarnarono lo spirito del romanticismo. Accanto alle più note George Sand e Emily Brontë, che aprono e chiudono la raccolta, Ferro sceglie di riscoprire donne che in vita parteciparono attivamente alla loro epoca, ma che furono poi dimenticate dalla storia: Marceline Desbordes Valmore, Marie d’Agoult, Marie Dorval, Delphine de Girardin, Juliette Récamier, Charlotte de Hardenberg, Éveline Hanska, Juliette Drouet, Louise Colet e Alphonsine Plessis. Questo oblio postumo, come abbiamo già detto, toccherà poi anche a lei, la quale era ben consapevole di questo rischio: «Per una donna che fa mestiere di penna è duro – e ammonitore, almeno per la vanità – constatare che il tempo, salvo rare eccezioni, annulla quasi sempre il suo lavoro. Molte sono le scrittrici che ebbero successo durante la loro vita e che poi il tempo ridusse a zero».8 L’attenzione che Marise Ferro porta alla condizione femminile è presente sin dai suoi primi romanzi, Disordine (1932) e Barbara (1934) (non ancora ristampati) e percorrerà tutte le opere successive incarnandosi di volta in volta in personaggi femminili perlopiù ribelli, che esulano dai canoni dell’epoca. Ma è soprattutto nella penna «lucida e crudele»9 della scrittrice, come la definirà Giuliano Gramigna nella recensione al romanzo del ’72 Una lunga confessione, e nello sguardo spesso ironico e impietoso che rivolge alla società, che ritroviamo una visione moderna della donna, ben distante dai dettami dell’epoca.

Le ultime (per ora) due ristampe ferriane datano del 2022 ed escono per l’editore Elliot, La ragazza in giardino e La violenza (originariamente pubblicato nel 1967). In entrambi i romanzi ritroviamo un’indagine serrata della condizione femminile attraverso le storie di due protagoniste accomunate da quel paesaggio dell’estremo Ponente ligure nel quale i romanzi sono ambientati. Nei due romanzi le due ragazze protagoniste sono figlie ribelli nate in un contesto borghese intessuto di rigidi rapporti formali che, nel caso di Antonia Orengo, protagonista de La violenza, acquistano una tinta fosca e, appunto, violenta. Mentre nel caso di Laura, protagonista de La ragazza in giardino, il testo sul quale ci soffermeremo, la ribellione passa da un’osservazione minuziosa e spietata del mondo degli adulti e attraverso un’iniziazione sessuale dirompente.
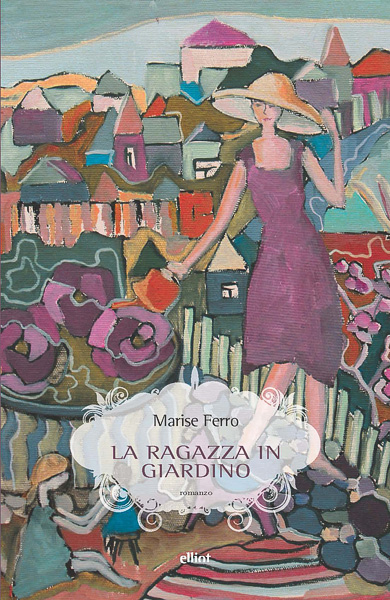
La ragazza in giardino fu pubblicato una prima volta nel febbraio 1976 ed è il penultimo romanzo scritto da Marise Ferro. Sulla copertina della prima edizione Rizzoli il profilo di una ragazza è immerso in una moltitudine floreale e arborea di un giardino con il mare sullo sfondo. La vicenda di Laura, infatti, è ambientata in una villa con giardino la cui ispirazione viene sicuramente da quella villa Hanbury de La Mortola con i suoi giardini di acclimatazione. All’inizio del romanzo Laura ha undici anni e vive a Villa Bra con nonna Leo, una donna ricca e austera, rigida nei modi e amante delle piante. È attraverso lo sguardo affilato di Laura e una voce schietta e capace di oltrepassare i rigidi confini delle convenzioni sociali che seguiamo le vicende della ragazza e del mondo che le gravita attorno, un universo borghese e familiare incentrato sul perno del denaro. Già solo l’incipit del romanzo ci dà un’idea di quanto questa voce risuoni un tempo altro rispetto a quello che la società ha costruito e come riesca a smascherarne il volto con disarmante facilità:
«Mio padre e mia madre non erano fatti per la famiglia, non amavano i bambini, un figlio era un impiccio, un essere che a stento riconoscevano appartenere alla razza umana. Erano due adulti egoisti che avevano generato per errore, ma che non volevano riconoscere e accettare il loro errore» (p. 39).
Oltre a nonna Leo ritroviamo dunque anche i genitori di Laura, lontani all’inizio del romanzo e che, più tardi, raggiungeranno Villa Bra più che altro per sbrigare faccende economiche che non per stare vicini alla ragazza.
La vita di Laura trascorre in uno spaziotempo che sembra chiuso e immobile. Costretta a vivere dentro la villa, lontana dai suoi coetanei se non per le ore trascorse a scuola, la sua infanzia è solitaria e gli unici dialoghi sinceri che trova sono quelli con Amalia, la governante. Una figura, quella della governante, che le permette di uscire dalla ristretta cerchia familiare incentrata sui discorsi del denaro e del lavoro, e di osservare questo mondo dal di fuori, da spettatrice. Le confessioni fatte ad Amalia sono un momento che scandisce il tempo del racconto e sono attimi di presa di distanza che permetteranno a Laura di avanzare nel suo percorso di iniziazione.
Nel ristretto perimetro della villa l’unico spazio di libertà per Laura è il giardino. E il giardino qui rappresenta davvero uno spazio altro, quasi un luogo magico capace di trasformare coloro i quali sanno attraversarlo, come Laura e nonna Leo, le quali spesso vi si dilettano in lunghe passeggiate tra fiori e piante. La figura della nonna, poi, viene spesso presentata come simbiotica al giardino «la morale non era mai entrata, credo, nei suoi pensieri. Ella era naturale, come il giardino» (p. 88), fino a diventarne l’anima: «da tempo non era più la mia carceriera, era la compagna benevola delle mie passeggiate in giardino, era l’anima del giardino stesso» (p. 123). Nonna Leo amava più le piante degli esseri umani e riteneva il tempo del giardino un momento sacro, da cogliere al volo, proprio perché fugace ed essenziale.
«Nonna Leo passeggiò sotto gli alberi per mezz’ora e per mezz’ora io dovetti seguirla perché mi illustrava ogni particolarità dei fiori. Ne colse uno rosa, col cuore quasi bianco, per mostrarmi come dal calice duro piuttosto volgare uscisse improvvisa quella meraviglia di grazia, uscissero piccole foglie tenerissime dai petali più leggeri e frastagliati che ricordavano il garofano. Il suo viso era così intento che non si accorgeva della mia trepidazione: io aspettavo mia madre di ritorno dalla clinica, ella davanti alla fioritura delle camelie l’aveva completamente dimenticata» (pp. 73-74).
L’aura del giardino ha un potere salvifico che però non è concesso a tutti i componenti della famiglia. La madre di Laura, per esempio, non ama il giardino, passa il tempo chiusa nella villa o in giro in macchina tra Nizza e la Costa Azzurra e viene spesso presentata come una donna triste, inquieta e devota al consumo. «La sua sensibilità è volta ad altre cose. Ma privandosi dello spettacolo della natura si priva di una grande gioia, anzi, di un ristoro del corpo e dell’anima» (p. 77), dirà un giorno nonna Leo a proposito della nuora. Il giardino dunque non è solo un luogo che possiamo attraversare, ma è un luogo che ci attraversa, che ci modifica, è un luogo vivo, in movimento e questo movimento non è possibile arrestarlo. Quando qualcuno ci prova, come Massimo, il ragazzo che Laura incontrerà ad un certo punto del racconto, fallisce e del giardino non riesca a catturare che qualche immagine scomposta.
«L’albero di gaggia, dipinto da Massimo, divenne mostruoso: un viluppo di rami, con qua e là delle macchioline gialle che dovevano essere fiori. Soffrii nel vederlo come se gli avesse fatto del male colpendolo con l’ascia o tormentandolo con la scure» (p. 145).
La vita di Laura, che trascorre monotona nel clima assolato della Liguria, tra la scuola e le passeggiate con nonna Lea, ad un certo punto verrà scossa da alcune vicende familiari importanti, ma saranno soprattutto altre le scoperte che marcheranno davvero la vita della ragazza. La prima è la scoperta della letteratura e la seconda è quella del sesso. Quando Laura accede per la prima volta alla biblioteca di Daria, una vicina di casa, resta subito folgorata dalla lettura e, da quel momento, inizierà a vivere anche un’altra vita, quella che trova nei libri.
«Dietro ogni mia azione, dietro ogni mio gesto compiuto verso nonna Leo, Alessandro, c’era il pensiero consolatore del libro che stavo leggendo, l’unica cosa che veramente mi importasse, che desse forma e forza alle mie giornate. Il libro e il giardino che accoglieva la mia lettura nel suo abbraccio silvestre» (p. 110).
Alla libertà del giardino dunque, si aggiungono la libertà della conoscenza, dell’intelligenza e delle storie che squarciano nuovi mondi. Per Marise Ferro, di formazione illuminista, la libertà intellettuale è un fondamento per la liberazione della donna. Lo studio, la preparazione e la lettura sono elementi centrali nella sua formazione (che avvenne in gran parte da autodidatta), ma sono anche elementi chiave di liberazione da una condizione femminile che spesso è mantenuta in uno stato di minorità, perché di ignoranza.
Anche l’iniziazione sessuale arriverà per Laura dirompente e si aggiungerà allo spazio di libertà della lettura e del giardino. Gli incontri con Massimo, nipote di Daria, diventeranno per Laura momenti privilegiati di allontanamento dalla vita rinchiusa della villa e spazi di libertà sempre in quel luogo altro che è il giardino. Anche in questo caso il giardino si dimostrerà l’unico spazio in grado di accogliere un amore fuori dalle regole imposte dalla classe sociale della ragazza, un amore dirompente e ossessivo vissuto perlopiù di notte tra i fiori e le piante del giardino, un’alcova in grado di trasformare i due giovani in «due esseri silvestri» senza volgarità.
La ragazza in giardino è un romanzo di iniziazione che racchiude molti elementi autobiografici dell’autrice, a partire dai luoghi nei quali è ambientato, il contesto familiare, la figura della nonna. È un’iniziazione, quella di Laura, che passa per il giardino, i libri e il sesso, tre elementi che si intrecciano e che sembrano racchiudere le tematiche predilette di Marise Ferro, l’attenzione al paesaggio naturale quale elemento vivo e, in parte, salvifico, la formazione intellettuale come strumento di emancipazione necessario alle donne, e una libertà di azione che esce dai rigidi canoni dell’epoca.
Lo spazio che Ferro dedica al paesaggio naturale nelle sue opere dimostra un’attenzione fuori dal comune per l’epoca nella quale i romanzi vengono pubblicati e un aspetto modernissimo che, tra l’altro, nella sua scrittura risulta del tutto naturale, come se non ci fosse bisogno di precisare che l’essere umano non può pensarsi fuori o al di là della natura che abita. Una natura che è abitata e, allo stesso tempo, come lo spazio del giardino, ci abita. In questo senso il giardino è un perfetto esempio del rapporto che è possibile istaurare tra l’essere umano e la natura, perché il giardino è uno spazio artificiale, modificato dall’uomo, e, come ci ricorda oggi il paesaggista francese Gilles Clément, è un’utopia, un sogno, come quel rêve babylonien che Bennet e Hanbury hanno realizzato con i loro magnifici giardini di acclimatazione. Gilles Clément, autore, negli anni Novanta del secolo scorso, del concetto di jardin planétaire sostiene che il giardino non sia semplicemente un décor, ma piuttosto uno spazio di armonia nel quale possiamo scrivere «l’idée qu’on a du meilleur de notre temps».10 Traslare quest’idea al Pianeta che abitiamo significa considerare la Terra come uno spazio finito, quale è, nel quale i viventi evolvono sotto lo sguardo degli umani. Degli umani che hanno la responsabilità di mantenere questo giardino, che è in costante evoluzione, in buono stato, scrivendovi ciò che di meglio occorre alla propria epoca.
Lo spazio del racconto di Marise Ferro è uno spazio preciso, delimitato, è lo spazio di una vita che si schiude, che evolve verso forme nuove e inattese e il giardino è la metafora vivente che permette la scrittura di quell’esperienza straordinaria che ci accumuna, che è la vita. Ci auguriamo, insomma, che i libri di Marise Ferro continuino ad evolvere verso la strada della riscoperta e a scrivere, per noi, il meglio del nostro tempo.
———
Note:
2) La storia del progetto di Thomas Bennet e degli altri proprietari del giardino è raccontata nel libro di Enzo Barnabà, Il sogno babilonese: Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera, Infinito Edizioni, Formigine, 2021, nel quale si legge: «Il suo rêve babylonien – la creazione di giardini a strapiombo sul mare che, facendo pensare a quelli pensili realizzati dalla leggendaria regina Semiramide, arricchiranno le coste mediterranee nel corso della Belle Époque – si è realizzato» p. 22.
3) È nel Purgatorio, la cantica più terrena di tutta la Commedia e nella quale Dante si prodiga in numerose descrizioni di paesaggi, che ritroviamo, nel canto III, i versi con i quali il poeta narra la difficoltà di accedere alla montagna del Purgatorio prendendo proprio ad esempio la via impraticabile che aveva già attraversato sulla costa ligure: «Tra Lerice e Turbia la più diserta,/la più rotta ruina è una scala,/verso di quella, agevole e aperta». Dante Alighieri, La Divina Commedia, Hoepli, 2000, Purg. III, 49-51, p. 319.
4) Le parole di Marise Ferro sono riportate nell’introduzione di Francesca Sensini a Le Romantiche, Succedeoggi Libri, Roma, 2021, p. 11.
5) Una donna moderna del secolo trascorso. Marise Ferro giornalista è il titolo di una raccolta di articoli curata da Francesca Sensini e Federica Lorenzi per Aracne Editrice e pubblicata nel 2020.
6) Marise Ferro, La guerra è stupida, Gammarò edizioni, 2020, p. 108.
7) Ivi, p. 130.
8) Dall’introduzione di Francesca Sensini a Le Romantiche, p. 9.
9) Ivi, p. 10.
10) Rencontre: Gilles Clément “Le jardin planétaire” – YouTube
———
Immagine di copertina:
un ritratto di Marise Ferro




