È di ontogenesi quello di cui dobbiamo parlare, non di ecologia. 1
Alcuni autori, che intrecciano pensiero occidentale a quello indigeno, stanno guardando l’Antropocene come crisi della linearità e della separatezza: una crisi epistemica, di interpretazione e comprensione del reale che riduce la complessità del mondo a una semplificatoria giustapposizione di elementi discreti e individualizzati.
Si tratta di una produzione vasta e diversificata, ma a titolo di esempio possiamo citare Davi Kopenawa e Bruce Albert, La caduta del cielo. Parole di uno sciamano yanomami; Come pensano le foreste. Antropologia oltre l’umano di Eduardo Kohn; di rilevanza il lavoro sul prospettivismo di Eduardo Viveiros De Castro con Déborah Danowski, Esiste un mondo a venire. Saggio sulle paure della fine.
Il mondo capitalista si è imposto a colpi di spianamento delle discontinuità, di risposte soluzioniste a questioni ecologicamente intricate, di centralità dell’umano nel progetto terraformante “di cittadinanza”. Per molte epistemologie e posizioni scientifiche, ogni essere è terraformante – ovvero crea mondo con l’agentività del suo esistere ecologico. La criticità, in questo caso, tuttavia, si riferisce alla pretesa umana di fare-mondo conformemente all’idea di città-cittadino, nella doppia articolazione che vede, da una parte, il recinto addomesticato e sotto controllo (la “città”) – e simmetricamente le zone di sacrificio estrattivo fuori di esso – e, dall’altra, i corpi (i “cittadini”) disciplinati dalla città stessa – dalle sue leggi, infrastrutture, regole sociali, costruzione di significato.
Ma ecco che l’Antropocene manifesto – se lo immaginiamo come una nebulosa di interferenze nel palinsesto pulito e ordinato della quotidianità normalizzata – sta aprendo o divaricando innumerevoli crepe in ogni sistema ritenuto sotto controllo.
L’irruzione di Gaia (si veda il saggio Isabelle Stangers, Nel tempo delle catastrofi. Resistere alla barbarie a venire) sta cambiando la nostra percezione e scheggiando quell’assetto cognitivo che chiamiamo modernità. Il pianeta che coabitiamo è diventato strano, sfuggente, incontrollabile, molto più grande (o, meglio, ridistribuito su ogni scala spazio-temporale) di quanto ci raccontano le rotte del neoliberismo globalizzato e la Blue Marble della NASA. L’Antropocene ci parla di dislocazione: di corpi, di temporalità, di identità, di riferimenti cognitivi e concettuali; ci parla di perdita e di trauma. Ma come suggerisce anche Timothy Morton nel suo recente saggio con Dominic Boyer, Iposoggetti, lo smarrimento è pieno zeppo di vitalità e di possibilità di fare-mondo dalle rovine.
Uno dei pensatori emergenti in questo ambito di ricerca è Bayo Akomolafe. Nato in Nigeria, si forma in ambienti occidentali(zzati) ultracristiani, conseguendo una laurea in psicologia e un dottorato in psicologia clinica. Dopo vari anni di attivismo e di docenza alla Covenant University di Ogun, un insieme di circostanze personali lo spingono a intraprendere un cammino di (ri)scoperta delle sue radici Yoruba e il desiderio di “diventare nero” (becoming black). Attualmente risiede a Chennai, in India. Co-fondatore dell’associazione The Emergency Network, insegna presso il Pacifica Graduate Institute in California e l’Università del Vermont; è anche Global Senior Fellow presso la Berkeley University. Il suo saggio, These Wilds Beyond Our Fences: Letters to My Daughter on Humanity’s Search for Home (North Atlantic Books, 2017) è in uscita in Italia per Exòrma con il titolo Queste terre selvagge oltre lo steccato. Lettere a mia figlia per far casa sul pianeta. Vari testi e saggi sono scaricabili gratuitamente dal sito PostActivism.
«La B maiuscola di Blackness è un’identità, la b minuscola di blackness è lo srotolamento dell’identità. Il diventare nero è la desiderante, non-linguistic-abile fioritura dei corpi oltre le coerenti unità dell’identità».2
Partendo dall’osservazione dell’ammasso di crisi antropoceniche e lasciata alle spalle l’apocalisse, Akomolafe si interroga su quali possono essere gli spazi di agibilità politica e le posture che ci aiutano a non replicare il paradigma che da “umani moderni” ci portiamo appresso e che ci tiene bloccati in quella che lui chiama tricarcerazione:3 corpi privilegiati arroccati e corpi discriminati incatenati, sempre in rapporto dialettico ma tutti soggetti alla medesima struttura della «nave schiavista».4
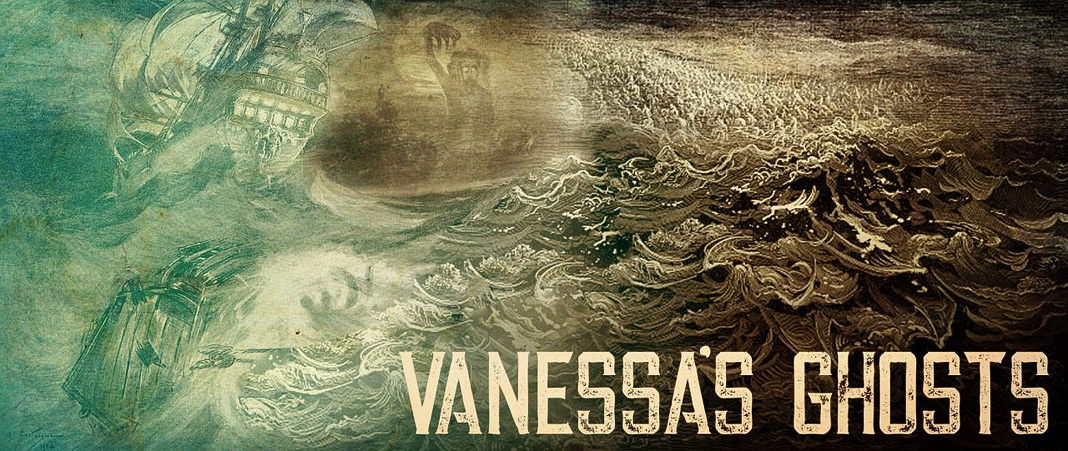
«Ora ci troviamo esattamente nell’assurdo. Le vecchie premesse newtoniane-cartesiane-copernicane che alludevano alla centralità dell’uomo – alla natura autoevidente della verità e alla promessa di arrivi luminosi e conquiste tecno- utopistiche – devono ora incontrare un vasto corpo tentacolare di microbi disciplinanti e licheni sbandanti e cirripedi stoici e lupi che ululano a una luna muschiata e, naturalmente, anatre che starnazzano. Tatuato su ogni parete rocciosa, ogni foglia feconda, ogni nuvola gravida c’è il monito che non ci sono ritorni a casa che non siano già dei punti di decollo o degli inquietanti luoghi di partenza; non ci sono progetti di ripristino che non siano già tentativi di eludere la stupenda spontaneità e vitalità del mondo. Per noi, embrioni in gestazione in questo grembo della modernità, la ricerca di comunità inizia in affinità con il mostruoso, con lo straziato, con l’imprevisto, con la confusione, con l’oscurità.
La lezione di Alethea è il nostro viaggio più terrificante e tuttavia la nostra speranza più potente: stiamo scendendo sulla terra e non arriveremo intatti».5
La sua elaborazione, che cuce le frontiere delle epistemologie “bianche” con le cosmogonie della tradizione Yoruba, felicemente difratta dall’uso della speculative fabulation 6 e dello storytelling, mette il dito nei grumi scomodi che intasano sia la discorsività mainstream che quella critica. Con un linguaggio poetico, ricco di tropi, ibridazioni linguistiche e neologismi ludici, sgombra il campo dalle categorie binarie del determinismo dialettico in cui siamo invischiati (nelle analisi così come nelle risposte), con un movimento “laterale” che non trascura gli aspetti del sacro fenomenico.
«Il sacro è un fare, un muoversi. Un verbo, non un sostantivo. Non una proprietà. […] Meglio ancora l’approccio è il sacro. Quando poi diciamo che tutto è sacro, intendiamo dire che tutto si muove, tutto sgorga, tracima, cedendo la propria integrità. Riguarda il come i corpi vengono incontro ad altri corpi, come i corpi usano o prendono in prestito altri corpi e sensi per rispondere alle sfide creative di una realtà multidimensionale che non è mai ferma – o come quei corpi in eccesso l’uno dell’altro creano nuovi spigoli e sperimentano nuove domande».7
Ed è proprio nel ragionare su corpi – come nodi di intensità, come condensazioni accidentali e temporanee di flussi ecologici, simpoietici, transcontestuali, co-prodotti – che Akomolafe esprime la sua visione de-Umanocentrica dalla doppia prospettiva ontologica e politica. Il frame filosofico postumanista è riferito alla transitorietà immanente dei corpi che ritroviamo in Emanuele Coccia: «Ogni vivente è un micro Leviatano che assembla in modo diverso i corpi più disparati ed eterogenei».8 D’altra parte, il «non arriveremo intatti» di Akomolafe è un monito ma anche un invito a sfilacciare l’Uomo, a inscriverlo come parte del metabolismo del pianeta, a “compostarlo”. Per Akomolafe quell’Uomo con la U maiuscola – che ha le sue radici nella tradizione illuminista – è infatti un “progetto cartografico” di strutturazione del mondo a misura di anthropos, la cui hybris di eco-costruzione, intra-specie e intergenerazionale è:
«il modo in cui gli alberi vengono abbattuti e gli ecosistemi ripuliti per fare spazio ai parcheggi, il modo in cui le popolazioni indigene nelle Americhe sono state sterminate, il modo in cui le montagne sono state fatte esplodere per costruire un porto per le navi che trasportavano generazioni africane in Brasile».9

E al posto del tempo lineare secreto dal prometeico progresso dell’Uomo – che ha storicamente assunto una posizione di dominanza, oscurando temporalità “rinnegate” e ora soggetto alle turbolenze dell’Antropocene – Akomolafe propone un’idea di tempo dilatabile, interrompibile, tattile, queer. Anche qui non si tratta di opporre un contro-concetto, come quel “circolare” che tanto spopola, bensì uno scarto a latere di tipo relazionale:
«Il tempo è come ci incontriamo, come ci salutiamo. Il tempo è come mangiamo, come sentiamo il mondo, il tempo è parte dell’apparato sensoriale. Il mio punto è che sembra che siamo bloccati in un fare-mondo che piace alla nozione di permanenza e continuità ad ogni costo. Ho coniato il termine cronofemminismo per sloggiare il tempo dalla sua marcia imperiale dal passato al futuro. È un mettere tra parentesi il tempo fallico e consentire l’emergere di altre temporalità. È un invito a guardare di nuovo, a guardare meglio, a una immaginazione ‘profetica’. Mi riferisco a come Deleuze parla di ‘diventare donna’, come un movimento verso un divenire al posto di uno statico modo di esistere. La pratica del commoning, del riunirsi e studiare le crepe sull’autostrada del dorato futuro è ciò che chiamo cronofemminismo».10

Ecco che ritornano le crepe, una delle tematiche ricorrenti in Akomolafe, assieme ai crocevia governati dalla divinità trickster Esu. Queste discontinuità sono topografie somatiche di rallentamento (slowing down) e osservazione del non-visto (the unseen). Che cosa resta fuori dal ristretto cono illuminato dai riflettori del panottico foucaultiano? Quali ipotesi può indicarci un pensiero sedizioso rintracciabile bordeggiando il margine in cui, tra luce e ombra, si annida ogni “spazio di radicale possibilità”?
«Le crepe diventano questioni di ontogenesi, siti di intercessione di ciò che deve venire e ciò che non è del tutto finito. La geofilosofia degna di nota oggi è probabilmente una politica che coltiva modi per seguire le crepe laddove potrebbero condurre».11
Crepe che, così configurate, ricordano da vicino quei dispositivi immaginativi di strutturazione cognitiva e sociale, di politica fuggitiva, che sono stati Chauvet o Lescaux quando, ieri, ci raschiava la pelle la calotta glaciale.12 Mentre oggi ci ruggisce in faccia un’invincibile estate.
Siamo già stati qui, molte volte: ci sono stati e ci sono un miliardo di Antropoceni, un miliardo di momenti in cui collassi ambientali e colonialismi predatori hanno distrutto i mondi. Tornare sulla-nella Terra non lascia intatti, certo, ma per concludere come abbiamo cominciato, con la lezione di Alethea:
«In un momento in cui non possiamo più permetterci di rimanere nascosti nei nostri bastioni fortificati […], credo che siamo invitati dentro una più sbalorditiva vivacità delle cose… in una comunanza di respiro. Un “noi” più denso».13
———
Note:
2) Libera traduzione dell’autrice dalla lecture “Bayo Akomolafe: Becoming Black – The Colonial Grammar of Settlement and the Promise of Fugitive Flight” della Sparta Kunstakademie Düsseldorf del 4 novembre 2021: https://youtu.be/NUXSjBMn94U
3) Libera traduzione dell’autrice dal talk “Cancel Culture and the limits of Identity Politics with Bayo Akomolafe” del 25 luglio 2020: https://youtu.be/3CaQ2Ggc7f0
4) È uno dei tropi ricorrenti in tutta la sua produzione, che descrive la condizione dei corpi nel mondo turbo-capitalista. Una nave strutturata secondo scopi e gerarchie coloniali che non ha mai smesso di trasportare vite (umane e alterumane) ed è diventata fisicamente il mondo neoliberista globalizzato e cognitivamente il modo di pensare dentro quel paradigma. A titolo esemplificativo, su questo tema, si segnala la lecture “Bayo Akomolafe. On Not Thinking Straight” dell’Institute for Philosophy and the New Humanities del 29 novembre 2021: https://youtu.be/3q-Q7FXvY3o
5) Libera traduzione dell’autrice da Alethea’s Lesson: Queer Homecomings and the Quest for Community, 2016: https://www.bayoakomolafe.net/post/aletheas-lesson-queer-homecomings-and-the-quest-for-community
6) Riprendendo la teoria dell’ottica, per Donna Haraway la forma della speculative fabulation è un sistema di diffrazione della narrazione patriarcale: se riflessione e rifrazione, dislocano il discorso riproducendo “il medesimo”, la diffrazione introduce e mappa le interferenze. Cfr. Le promesse dei mostri, 2019, DeriveApprodi, p. 56.
7) https://www.postactivism.org/2023/02/18/il-sacro-e-un-verbo-non-un-sostantivo/
8) E. Coccia, Metamorfosi. Siamo un’unica, sola vita, Einaudi, 2022, p. 131.
9) B. Akomolafe, Io Coronavirus. Madre. Mostro. Attivista, scaricabile in PDF da https://www.postactivism.org/2023/01/08/io-coronavirus-madre-mostro-attivista/
10) Libera traduzione dell’autrice dal suo intervento al Forum WFSF (ONG partner dell’UNESCO) 26-29 ottobre 2021, Berlino. Disponibile al link https://youtu.be/QfylcTHTeI8
11) Libera traduzione dell’autrice dal suo post su Facebook: https://www.facebook.com/bayoakomolafeampersand/posts/pfbid0g9oQ7yG9qpZGdJow2fAwhNQ2RZqeqDJQ62X9n81LnYZcm2pXSXhKm2oSam3dRVhEl
12) Cfr. Matteo Meschiari, Disabitare, Meltemi, 2018, p. 34.
13) Vedi nota 3.
———
Illustrazioni:
© Jon Marro per Bayo Akomolafe




