«Se la crisi ambientale in cui versa l’umanità comporta tanto uno stato di coscienza paralizzato quanto un habitat danneggiato, allora è forse da qui che dovremmo iniziare» (Paul Shepard, Teneri carnivori. Cacciatori e selvaggina sacra, Meltemi, 2023, p. 32).
Dal 2013 al 2018 ho lavorato in un magazzino di produzione e stoccaggio, sede di una grande azienda di moda italiana, nel cuore della Pianura Padana. I magazzini che ricoprono la Grande Pianura sono tutti uguali: bassi, rettangolari, rivestiti di lamiera, senza finestre, alcuni espongono marchi o indicazioni, altri restano anonimi tasselli di un enorme agglomerato metallico. Basta percorrere l’Autostrada del Sole, o passare su un treno a media o alta velocità, oppure perdersi tra le strade basse allineate tra i fossi per incontrarne a centinaia, a migliaia. Migliaia di fabbricati tutti uguali che scricchiolano al sole, scogli sul fondale di un antico mare arrugginiti dalla nebbia, non di rado scheletri vuoti, testimonianza di tangenti spese a vuoto o di fallimenti e abbandoni. Nel magazzino trascorrevamo cinque o sei giorni a settimana dalle otto alle dieci ore (fino a quindici ore) immersi nella luce artificiale, nel caldo che, all’interno, in estate raggiungeva i 39 gradi e nel freddo che, in inverno, si trasformava in correnti d’aria gelata che entravano dai portoni del carico-scarico. Non di rado le sirene di un’ambulanza indicavano che qualcuno (più spesso qualcuna) di noi si era sentito male: per il caldo, per la claustrofobia, per i ritmi di lavoro troppo alti. In un bagno di un magazzino vicino, qualcuno aveva scritto sulla porta: lasciate ogni speranza o voi che entrate. Una versione presente del Benvenuti all’inferno in Metallo urlante di Valerio Evangelisti, principio della saga che indaga la nascita del capitalismo industriale, quando Clarissa scappa terrorizzata e arriva all’entrata di una caverna e Wagner le dice «laggiù non c’è nessun dio. Né Vulcano né Ogun. È il metallo che portiamo addosso che sogna i propri dèi» (p. 58).
Ogni giorno ripetevamo gli stessi gesti, molti di noi trasportavano carichi troppo pesanti rovinandosi la schiena, tutti quanti andavamo e tornavamo dal lavoro percorrendo le strade nelle ore di punta, chiusi negli abitacoli delle nostre automobili respiravamo l’aria di una delle città più inquinate d’Italia, che ancora nel 2022 segnava una media annua di concentrazione di pm10 di 32 microgrammi per metro cubo.
Un pomeriggio d’autunno del 2016, seduta nella cucina dell’appartamento che condividevo con due amiche nella periferia della città, mentre parlavo al telefono, ho perso i sensi rovesciando il bicchiere d’acqua che c’era sul tavolo e richiamando così l’attenzione della mia coinquilina, la quale ha potuto soccorrermi. Quello fu il primo di una lunga lista di episodi che videro l’alternarsi di malori improvvisi, attacchi di panico, nausea, allucinazioni visive e uditive. Nel tempo scoprii che molte altre persone che lavoravano lì presentavano sintomi simili ai miei, molti assumevano psicofarmaci, altri vivevano situazioni anche più gravi. Un giorno una donna uscì dal lavoro, guidò per circa un’ora di strada, salì su una montagna dell’Appennino e si gettò nel vuoto.
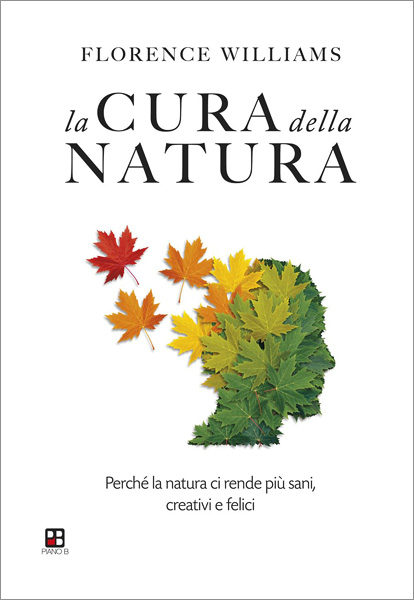
Se ripercorro queste esperienze passate è perché mi sono tornate alla mente (e al corpo) in maniera prepotente mentre leggevo il libro della scrittrice e giornalista statunitense Florence Williams, La cura della natura, pubblicato quest’anno da PianoB Edizioni nella traduzione di Antonio Tozzi. Un libro che indaga, attraverso l’incontro con diversi scienziati in alcuni Paesi del mondo, l’importanza che ha avuto e che ha l’ambiente naturale per l’animale umano. Un’importanza che, come mostrano ormai diverse ricerche e sperimentazioni, agisce a livello biologico, sul sistema nervoso, così come l’allontanamento da questo ambiente produce conseguenze altrettanto profonde. Scrive l’autrice: «Il nostro sistema nervoso è fatto per rispondere e risuonare a certi stimoli derivati dal mondo naturale: oggi la ricerca sta confermando quello che i romantici sapevano già» (p. 13). La lettura della storia di Williams, che prende le mosse dalla sua esperienza personale di un trasloco da un piccolo paese di montagna a Washington DC, con tutta una serie di conseguenze che la spingono a intraprendere questa indagine sull’importanza della natura, ha riattivato memorie della mia esperienza di allontanamento dai luoghi naturali e della discesa agli inferi nel paesaggio metallico del produttivismo capitalista. Probabilmente l’esperienza più estrema che abbia avuto finora di modificazione psicofisica dettata in gran parte dall’attività che dovevo svolgere, e che milioni di persone continuano a svolgere in quello che ormai è diventato un mondo logistico e dal luogo che abitavo. E il luogo che abitiamo conta, e conta parecchio. La cura della natura
«vuole esplorare la scienza che sta alla base di quello che i poeti e i filosofi sembrano sapere da secoli: il luogo conta. […] In ambienti diversi ho notato alcune variazioni piuttosto drastiche del mio umore, della mia creatività, della mia immaginazione e produttività, e ho iniziato a rifletterci». (pp. 12-17).
Le micro-narrazioni della mia esperienza nella catena industriale e del trasloco di Williams sono solo esempi di trasformazioni più grandi che avvengono, a una velocità sempre maggiore, su scala globale: il settore industriale supera il settore agricolo e homo sapiens, come riporta l’autrice, è diventato ufficialmente una specie urbana nel 2008 (p. 21).
Poco tempo dopo il suo trasferimento nella grande città e il carico di disagio causato dal rumore costante e dalla difficoltà di trovare spazi verdi, Williams parte per il Giappone con l’incarico di scrivere un articolo sul forest bathing. Questa pratica è nata in Giappone negli anni Ottanta e ormai viene messa in pratica in molti altri Paesi. In quel decennio fu lo stesso Ministero dell’Agricoltura giapponese a promuovere e riconoscere gli effetti benefici delle camminate nei boschi, individuando nei fitocidi un elemento in grado di apportare benessere psicofisico negli esseri umani. I fitocidi sono sostanze rilasciate dagli alberi, in particolare conifere e sempreverdi, in grado di proteggere la pianta stessa da batteri e agenti patogeni e che, negli umani, riducono la presenza di cortisolo nel sangue e stimolano il sistema parasimpatico, responsabile di stati di rilassamento, quiete e riposo. «Anche il suolo è ottimo per la guarigione. È antivirale, e la geosmina ha proprietà antitumorali» (p. 78). La geosmina è quel composto che genera l’odore che ha la terra dopo la pioggia. I cammelli nel deserto possono sentire questo odore a chilometri di distanza, l’odore della sopravvivenza. A partire dal 2003 in Giappone sono stati stanziati milioni di dollari nella ricerca di almeno cento siti di terapia forestale nei quali i giapponesi, la maggior parte dei quali abita a Tokyo e vive una vita di stress lavorativo molto elevato, possono andare per ritrovare un antico legame con le foreste e con l’ambiente.
Il legame con l’ambiente naturale è l’elemento dal quale prende le mosse la ricerca di Williams e viene esplicitato attraverso «l’ipotesi biofilia». L’antropologo giapponese Yoshifumi Miyazaki, infatti – intervistato dalla giornalista in occasione della ricerca sul forest bathing – è un sostenitore della teoria sviluppata dall’entomologo Edward Osborne Wilson in una serie di saggi pubblicati in Italia sempre da Piano B, Biofilia. Il nostro legame con la natura. Secondo Wilson esiste un legame innato tra gli esseri umani e gli altri organismi viventi e l’esplorazione del mondo vivente è un fattore cruciale dell’evoluzione umana. Questo spiegherebbe, oltre alle reazioni che abbiamo e che ci aiutano ad evitare pericoli, anche la predilezione per certi luoghi. Spiega Miyazaki:
«[n]el corso della nostra evoluzione abbiamo trascorso il 99,9% del nostro tempo nella natura, e la nostra fisiologia è specificamente adattata a quel contesto. Nella vita di tutti i giorni, se i nostri ritmi sono sincronizzati con quelli dell’ambiente intorno a noi, riusciamo a raggiungere una sensazione di comfort» (p. 33).
Il viaggio di Williams prosegue con il ritorno negli Stati Uniti e con l’incontro di un gruppo di scienziati guidati da David Strayer dell’Applied Cognition Lab dell’Università dello Utah. Mentre i giapponesi studiano la connessione tra l’umano e la natura, Strayer e compagni sono impegnati a misurare quanto la natura aiuti l’essere umano a pensare e risolvere problemi. Un gruppo di neuroscienziati, psicologi e ricercatori passa diversi giorni nella natura senza telefoni o dispositivi per ragionare insieme sulle connessioni tra natura e cervello umano e per capire con un certo grado di precisione quante «dosi di natura» ci occorrono per recuperare da uno stato di stress.
Partendo da questi due diversi approcci la ricerca di Williams prosegue per gradi, ovvero andando a sperimentare l’aumentare del tempo passato in natura attraverso diverse esperienze in diversi Paesi, dalla scienza dell’escursionismo in Corea del Sud, alle «terapie dell’avventura» in Scozia, alle cinque ore di natura al mese raccomandate dai finlandesi, fino all’immersione in una natura ancora selvaggia intorno al fiume San Juan in Colorado. Ma, soprattutto, l’autrice indaga l’evoluzione e l’affievolirsi dei nostri sensi e la memoria paleolitica che li custodisce.
«Le dimensioni del nostro cervello e della nostra muscolatura hanno raggiunto l’apice durante l’ultima era glaciale. In seguito i nostri denti sono diventati più piccoli e la nostra visione a distanza è peggiorata. Da quando ci siamo stabiliti in comunità agricole, circa diecimila anni fa, siamo diventati più deboli e certamente, per molti versi, più stupidi. […] I nostri cervelli si adattano a gestire la vita moderna, persino da un anno all’altro – ma questa non è evoluzione, è flessibilità. Nello sfasamento tra le nostre vite e i nostri cervelli attuali, la vittima principale è il nostro sistema nervoso paleolitico. Non c’è da stupirsi, quindi, se ci sentiamo felici quando sentiamo un odore davvero buono. È come se, anche solo per un istante, facessimo un salto in un altro mondo» (pp. 89-90).
I nostri sensi si stanno affievolendo quando non addirittura scomparendo. Molti geni che regolano l’olfatto non sono più attivi non essendo più uno dei sensi indispensabili alla nostra sopravvivenza. Il tasso di miopia negli adolescenti supera il 90% e gli scienziati sono ormai concordi sul fatto che questo dipenda dal tempo trascorso a vivere in spazi chiusi e con scarsa luce naturale. Altri sensi, come l’udito, che è il nostro maggiore senso di allerta, sono disturbati dal «paesaggio antropofono», ovvero il paesaggio sonoro creato dagli umani, un paesaggio costantemente rumoroso. «Tutti noi interagiamo con l’ambiente attraverso i nostri sensi, quindi qualsiasi inquinamento influisce non soltanto sulle strutture delle nostre vite, ma anche sulle nostre connessioni con tutto il resto» (p. 108), sostiene lo scienziato bioacustico Kurt Fristrup. La serie di rumori alla quale siamo sottoposti nelle città fatica a essere elaborata dal nostro cervello e questo crea stati di ansia e deconcentrazione. Insomma olfatto, udito e vista sono i sensi che ci hanno accompagnato nell’evoluzione, che sono stati fondamentali, e che ora stiamo danneggiando creando soggetti con sempre maggiori disturbi fisici e psichici, salvo poi spendere milioni per studiare metodi che possano riportarci a stati di equilibrio o creando realtà virtuali che siano «mondi rigenerativi», come il progetto ReLIVE che la stessa autrice ha sperimentato.
Che passare del tempo nella natura faccia bene sembra una cosa ovvia, così come oggi è ovvio sostenere che «fare attività fisica protegge il cervello dal declino cognitivo dovuto all’invecchiamento» (p. 49), sebbene quest’ultima affermazione prima degli studi di Art Kramer negli anni Novanta non fosse affatto scontata. Tuttavia, la questione è così ovvia che in pochi saprebbero davvero argomentarla, forse perché è raro soffermarsi sugli effetti che l’immersione nella natura produce nel corpo e nella mente, sempre più difficili da ottenere in un ambiente sacrificato. Il pregio del libro di Williams è di fornire risposte precise a questioni solo apparentemente ovvie, e di farci riflettere su quanto già abbiamo perso e quanto ancora perderemo, continuando ad accelerare la costruzione di un mondo esclusivamente umano. E tuttavia la conoscenza non è sufficiente. Come sosteneva Paul Shepard
«mettere l’ambiente “là fuori”, al di fuori di noi, lo ha reso invisibile. Il fallimento dell’azione ecologica non dipende dalla nostra disponibilità al cambiamento, ma da qualcosa che si può vedere solo guardando leggermente al di là della questione ambientale stessa» (P. Shepard, Teneri carnivori, p. 28).




