Derek Raymond, Il mio nome era Dora Suarez
Nel 1992 Derek Raymond, forse cosciente di essere vicino alla fine della sua vita dissoluta (morirà infatti due anni dopo), pubblica The Hidden Files, tradotto in Italia nel 2011 con il titolo Stanze Nascoste da Meridiano Zero, e ormai da tempo, fuori catalogo.
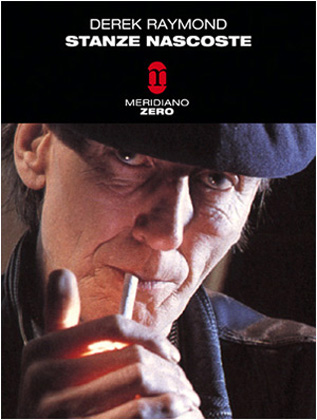
Nato il 12 giugno del 1931, rampollo di una famiglia aristocratica inglese e cresciuto nel castello dagli antenati, Raymond inizia presto a ribellarsi. Gli unici momenti felici dell’infanzia li sperimenta durante le sue fughe, quando scopre l’esistenza di un mondo dal quale i genitori lo tengono lontano: quello della strada. La guerra busserà anche alle porte della sua elegante dimora, mostrandogli gli orrori dell’uomo. Comprende la distanza fra i privilegiati come lui e il resto del mondo destinato alla rovina. Giunta l’adolescenza si iscriverà a Eton per volere della famiglia e seguendo la tradizione dell’aristocrazia inglese. In quella scuola ritrova l’opprimente conformismo dell’ambiente famigliare. Di nuovo si ribella e viene spedito in un’altra scuola, ma sarà un altro insuccesso, e infine si arruolerà nell’esercito, esperienza che considererà in seguito molto più formativa, sebbene non manchino i tentativi di evasione anche da quel contesto. Dopo il congedo e interrotti i legami con la famiglia d’origine, si tuffa nelle strade, dedicandosi ai mestieri più miseri e improbabili, viaggia per il mondo venendo a contatto con un’umanità pericolosa ma molto più interessante. È questa la sua vera formazione, quella che gli consentirà di scrivere. A partire dagli anni ’60 pubblicherà un ciclo di romanzi noti come Factory Series, che lo porterà al successo.
«1. Il noir non è letteratura d’evasione. Lo scrittore non può fuggire alla sue responsabilità, e nel noir ogni tipo di evasione è preclusa.
2. Lo scrittore deve diventare parte dei personaggi, e loro devono diventare parte di lui.
3. Lo scrittore corre un serio pericolo perché deve cancellare ogni distanza tra se stesso e i personaggi – alcuni dei quali estremamente poco raccomandabili. Deve lasciarsi assorbire fino al punto di dimenticare che sta scrivendo, fino al momento in cui lui diventa la stanza, la strada, la situazione, la gente che racconta e i personaggi cominciano a esistere per suo tramite, diventando reali sulla carta come se stessero vivendo – o morendo – per la seconda volta.
4. In ogni caso alla fine dell’opera lo scrittore deve aver provato gli stessi sentimenti di colpa e di terrore dei personaggi. Al libro non gliene frega niente, di quello che fa l’autore per scriverlo, ma ai personaggi si. E sono loro i veri giudici» (da Stanze Nascoste, p. 146).
Non è facile definire Stanze Nascoste, in cui pagine di memorie sparse si sovrappongono a poesie, lettere ad amici, analisi sociale, psicologica e letteraria. In poche e brevi pagine, Raymond mette a nudo non solo i suoi mostri, ma quelli che abitano ognuno di noi, nella consapevolezza che nessuno è innocente.
«Se conoscessi la vera natura del male sarei un intellettuale. Ma non la conosco e non lo sono, non ho alcun bisogno di esserlo. Il male sono le linee nemiche. Affrontarle è essenziale. Attacchi ciò che è sbagliato perché è sbagliato. Non occorre pensarci su, lo sai e basta. Spesso la cosa sbagliata è dentro di te, ed è ancora più difficile da combattere perché fa parte di te. Eppure devi farlo, altrimenti firmi un patto col male, che è come ammettere di essere stato sconfitto» (p. 175).
Si tratta del suo testamento spirituale, un manuale di sopravvivenza non solo per gli scrittori, ma rivolto a tutti. È la testimonianza di un uomo e del compito doloroso di cui ha deciso di farsi carico per dare voce ai più deboli, ai disperati, ai morti, a tutti coloro che la società ha escluso:
«Si potrebbe dire che lo scopo del noir sia mostrare tutta la merda che lo Stato, come una vecchia domestica isterica, cerca costantemente di nascondere sotto il tappeto. Il noir solleva il tappeto davanti al maggior numero di gente possibile, dicendo: “Non pensate anche voi che qua sotto ci sia una gran puzza di merda?”» (p. 178).
Per mostrare tutta il marcio della società lo scrittore, o il detective, dovrà dunque calarsi nei panni delle vittime. Raymond non si illude, sa di essere egli stesso un poveraccio come tanti, sa anche che il marciume non avrà mai fine, ma non per questo bisogna gettare la spugna. Lo scrittore può andare oltre come fece Raymond, vivendo i suoi racconti in prima linea, immischiandosi con veri criminali, assassini e depravati, rischiando la galera, la follia, l’assassinio. Lo scrittore non può essere un privilegiato, protetto dai contorni della sua stanza e delle sue pagine: deve invece sporcarsi le mani, come tutti. Solo così la sua lingua sarà viva e non morirà sulla pagina. Per Raymond non ci sono sconti di pena, non ci sono mezze misure. È chiaro: non si può parlare di ciò che non si è vissuto.
«Nel complesso la verità su me stesso mi pare alquanto orribile, ma non ha senso cercare di analizzare oscuri omicidi, liquidati dalla stampa in una decina di righe in terza pagina, senza prima conoscere quella verità. E sono anche consapevole di questo: nessuno potrà dirmi chi sono veramente se non lo scopro da solo» (p. 187).
Raymond ha cercato per tutta la vita di combattere contro la parzialità nella visione delle cose, la separazione della letteratura in categorie, la disinformazione e soprattutto l’indifferenza nei confronti degli altri, quest’ultima la vera causa della nostra degenerazione morale. Ciò di cui egli scrive in Stanze Nascoste è tremendamente attuale, specie considerando l’infima qualità dell’informazione contemporanea, la spettacolarizzazione del dolore, e il modo in cui le vite e le sofferenze altrui vengono gettate in pasto ai giornalisti e ai commenti sulle piattaforme, dove al riparo di uno schermo e di una tastiera si giudica, si colpevolizza e si specula senza conoscere i dettagli più intimi delle vicende. In questi giorni oppressi da notizie sulla guerra e violenze efferate, non possono non scuotere parole come queste:
«Uno dei crimini che l’umanità non sa di commettere è il sensazionalismo – basta chiedere a un giornalista. Ma non c’è niente di sensazionale nell’omicidio. Nessuno spettatore normale potrebbe mai provare piacere a essere testimone di un omicidio violento commesso con brutalità e oscena ferocia. Poche persone avrebbero il fegato di assistere anche solo ai preliminari; la curiosità morbosa dello spettatore sarebbe placata in cinque secondi netti e una volta per tutte» (p. 202).
Per Raymond non sono importanti i particolari del delitto. Quelli li lascia ben volentieri ai gialli e i polizieschi scritti per vendere e intrattenere. L’omicidio non è uno spettacolo. Quel che importa secondo Raymond è la giustizia, è restituire dignità alle vittime entrando nella loro coscienza attraverso un’unione mistica, vivendo ciò che hanno vissuto, pensando ciò che hanno pensato. Fa ciò senza autocompiacimento o moralismi, con la consapevolezza del fallimento e dell’estrema fragilità delle nostre vite e delle nostre identità. Il sergente senza nome, protagonista della serie Factory, non ignora le vittime, e non solo perché è il suo mestiere ma perché per lui è una missione. Non ignora neppure gli assassini, non punta il dito contro di loro, ma li vuole conoscere. Nelle sue memorie, Raymond confessa di aver sempre temuto di potersi trasformare in un assassino. Questo timore lo ha portato ad analizzarsi e analizzare chi gli stava attorno. Il risultato più straordinario di questa analisi si trova in Il mio nome era Dora Suarez, considerato l’apice della sua produzione, che contiene una descrizione accurata di uno psicopatico.
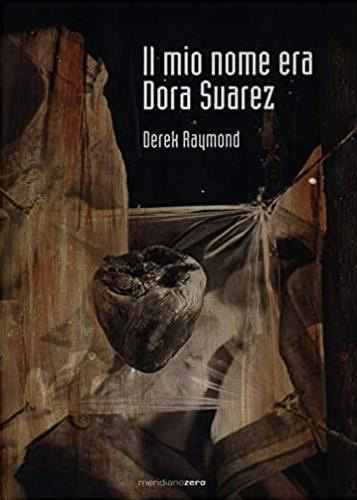
«Ci troviamo di fronte a persone che infliggono il dolore senza avere idea di cosa significhi, perché per prima cosa se lo infliggono su di sé. Una donna, una farfalla… per un sadico sono la stessa cosa. Nel loro caso la violenza sostituisce l’amore. O, meglio, per loro la violenza è amore. Gli psicopatici non hanno modo di rendersi conto di quello che stanno facendo. Per il resto sono perfettamente normali: guidano una macchina, vanno a lavorare, a volte addirittura si sposano. Per un po’ funziona, compresi figli e tutto il resto, finché qualcosa esplode, e allora siamo chiamati. Lo so bene» (p. 204).
Tuttavia, Raymond non condanna lo psicopatico in quanto individuo, ma sa che egli è il frutto della società in cui è nato. Il motivo per cui qualcuno soffre la violenza altrui o viene ucciso non risiede esclusivamente nel fatto che l’assassino è libero di agire, ma anche perché la vittima è stata lasciata da sola, già nel momento in cui la società ha deciso di ignorare i comportamenti di chi potrebbe fare del male.
«Né la medicina né lo Stato dedicano la dovuta attenzione al rapporto di causa ed effetto tra l’omicida, la famiglia, l’ambiente e i fattori sociali o le esperienze che possono aver portato i genitori a comportarsi a loro volta in un certo modo con il figlio tanto da spingerlo a diventare un assassino, trasformandolo in un mostro. Dirò di più: l’atteggiamento di scarso interesse adottato dallo Stato verso la sicurezza fisica della popolazione è sintomatico della crescente indifferenza generale nei confronti della vita umana» (Stanze Nascoste, p. 321).
Raymond scriveva queste parole nei primi anni Novanta ed è spaventoso constatare quanto poco sia cambiato.
Le stanze nascoste albergano in tutti noi. C’è chi vuole attraversarle e chi le rifiuta, ma prima o poi tutti siamo chiamati a riconoscerne l’esistenza. Raymond ha trovato nella disperazione la sua vocazione e ne ha fatto la sua arte. Attraverso la sua scrittura ci ha mostrato che la redenzione esiste e per questo non possiamo che essergli grati.




