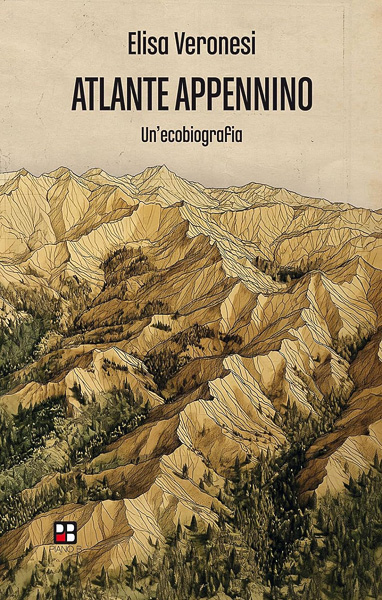[Pubblichiamo un estratto da “Atlante Appennino. Un’ecobiografia” di Elisa Veronesi, per gentile concessione dell’editore Piano B Edizioni]
Sull’Atlante
Quando Gerardus Mercator intitolò Atlas il suo libro di carte geografiche e disegnò la prima mappa del mondo, gli olandesi si apprestavano a creare la prima società capitalista moderna. Il mito al quale Mercator pensava era quell’Atlante greco, figlio di un titano e di un’oceanina, che dovette, per volere di Zeus, con la sola forza delle braccia, sostenere il peso della volta celeste. Votato all’astronomia, Atlante fu il primo a rappresentare il mondo per mezzo di una sfera e la sua figura giunge sino a noi, da un lato, pietrificata da Perseo e trasformatasi nella catena montuosa che attraversa l’Africa del Nord, dall’altro, come quella di colui il quale regge il peso del mondo. E fu proprio quest’ultima l’immagine che Mercantor scelse per il frontespizio del suo Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura.
Visto con i nostri occhi di oggi, questo mito, che diventerà per antonomasia il nome di tutte le raccolte cartografiche successive, fa risuonare l’eco di una volontà di espansione e dominio che, iniziata con gli europei del Cinquecento, non sembra volersi arrestare. Il moderno Atlante, infatti, non avrebbe tanto retto il peso del mondo, ma lo avrebbe piuttosto circumnavigato, colonizzato, invaso, cambiato per sempre e spartito a tavolino tra spagnoli, olandesi, inglesi e francesi. Atlante diventa così il simbolo della potenza coloniale che si sente in diritto di tracciare linee, costruire rotte, annientare culture e che, a partire dagli stermini di massa nel continente americano, passando per l’invenzione della macchina a vapore e l’estrazione di carbone del XIX secolo, fino alla grande accelerazione del secondo dopoguerra, nel giro di qualche secolo, ci porta dritti al mondo che abitiamo.
Sarebbe forse il caso di abbandonare questo mito e smettere di disegnare mappe per affrancare finalmente la Terra dalla smania geometrica e contabile dell’esclusività capitalistica e, prima ancora, neolitica.
Eppure è Atlante la prima parola che mi è venuta in mente mentre camminavo, dialogavo, scrivevo, fotografavo in Appennino. E non per volontà di potenza, ma, all’opposto, per un sentimento di totale impotenza. Che è un odierno sentire comune, perché chiunque osservi le carte del mondo oggi, che siano esse fisiche o geografiche o che rappresentino l’urbanizzazione, la deforestazione, l’inquinamento atmosferico e luminoso, le acque morte, le coste erose, i ghiacciai disciolti, chiunque osservi questo mondo, oggi, da qui, chiunque sia a conoscenza del riscaldamento globale, della sesta estinzione di massa, dell’innalzamento del livello dei mari, dell’acidificazione degli oceani, non può che sentirsi impotente e sconfortato. Come reggere il peso del disastro?
Il paradosso di un’epoca antropocenica che vede elevarsi ad assoluto la potenza umana e ne evidenzia, allo stesso tempo, l’impotenza. Quando giriamo le chiavi della nostra automobile, dice Timothy Morton, sappiamo di stare inquinando il Pianeta, eppure la nostra sola automobile è «statisticamente irrilevante». Il nostro consumo è allo stesso tempo letale e inutile. «Proprio come avviene nei noir: sono allo stesso tempo il detective e il criminale! Sono una persona. Faccio parte anche io di un’entità che è diventata una forza geofisica che agisce su scala planetaria». Viviamo in loop temporali, paradossi, scale diverse, ordini di grandezza spaesanti e non udiamo lo scricchiolare di una calotta lontana migliaia di chilometri, non vediamo la crepa nel muro sotto al portico, che, lenta, si fa strada in pochi anni col franare della terra in secca. Oppure vediamo e sentiamo tutto questo e incominciamo, frenetici, a parlare di ritorni alla natura, inauguriamo parchi, santifichiamo paesi ribattezzandoli borghi, ci ritagliamo angoli verdi e lasciamo fuori il resto che, indisturbato, continua a spremere CO2 nell’atmosfera. Ci riempiamo di tecnologia, che, ancorché dematerializzata, è prodotta con pietre e metalli cavati fuori dalla terra a mani nude. Ci dematerializziamo, alcuni esemplari della nostra specie vivono in orbita in una stazione spaziale, altri, i pochissimi, preparano bunker e ibernazioni, altri ancora, i molti, si ricacciano dietro nazionalismi e chiusure stagne. I «terrestri», popolo in via di formazione, dal canto loro, sono consapevoli che la sola realtà nella quale riprendere vita è quella che i geologi chiamano «zona critica», una minuscola pellicola tra la Terra e l’atmosfera, nella quale, ancora, la vita continua a brulicare e le piante a sintetizzare ossigeno. È qui che camminiamo ed è qui che abitiamo. Non in un globo, ma in un giardino planetario limitato del quale occorre prendersi cura, non tanto e non solo per proteggere la natura, ma per proteggerci da noi stessi, da una potenza che ci sta facendo sprofondare in un caos ecologico e sociale.
Atlante oggi è un luogo di rovine. Di memorie sparse e anacronistiche che hanno funzione mnesica comune. Di resti di navi e città che ritroviamo nelle mattine di un’estate in secca come manifestazioni dell’epoca che stiamo attraversando, come possibilità in divenire, frammenti sconclusi, faglie da attraversare.
L’Appennino oggi è un luogo di rovine, e la necessità di dirne i resti ne conferma la sparizione. Una fine sancita dalla grande fuga degli anni Sessanta, della quale oggi possiamo misurare la portata e prendere atto dell’avvenuta mutazione antropologica, botanica e sociale. Non per inutili operazioni di storiografia nostalgica, né per ricreare atmosfere ad uso turistico, ma per aprire orizzonti e disegnare le carte del mondo che vorremmo attraversare, che altri dovranno abitare. E per farlo potrebbe essere utile anche riconoscerne spazi naturali diversi da ciò a cui secoli di lavoro dell’uomo ci hanno abituati, consapevoli di essere una specie così tanto nuova rispetto a tutto quello che accade, che esiste, che osserviamo e che ci osserva.
L’Appennino, sulle carte moderne, è plurale: gli Appennini, sistema montuoso che attraversa la Penisola e si declina in diverse specificità locali, come suggeriva già Antonio Stoppani in uno dei primissimi testi di «cognizione fisica» del territorio. Per ragioni biografiche di chi scrive, in questa ecobiografia, lo si declina al singolare, Appennino, trattando quasi esclusivamente di Appennino Settentrionale, quello che viene comunemente individuato a nord da Bocchetta di Altare, in Valle Bormida, e a sud dalla zona compresa tra i valichi di Bocca Serriola e Bocca Trabaria, ma che è geologicamente molto più fluido e complesso di così. La sovrapposizione tettonica delle falde orizzontali ha infatti riunito due domini paleogeografici molto diversi: una parte interna detta liguride e una parte esterna umbro-marchigiana. L’esterno è caratterizzato da zone calcaree, mentre l’interno, la cui storia si intreccia alla formazione alpina, si è originata dall’oceano ligure-piemontese. E qui non si racconterà nemmeno di tutta questa porzione di territorio, ma più specificatamente di Appennino Emiliano, il quale deborda facilmente di là dal passo diventando in un baleno Tosco-Emiliano, e di Appennino Ligure, con le sue valli strapiombanti a mare. Ma se si tracceranno indicazioni geografiche sarà solamente per un inevitabile legame, anche giuridico, che tutti quanti ci portiamo appresso da quando Homo sapiens e diventato stanziale e, tempo dopo, burocrate: un luogo di nascita, un indirizzo.
E se si parlerà di territorio sarà solamente per uscirne il prima possibile, perché non è di delimitazioni che si tratta, semmai di zone liminali, di sconfinamenti. Così come svalicano i passi ed erodono le gobbe calcaree, l’Appennino sborda le geometrie mentali, trattiene a stento le moderne innovazioni e sfugge i confini linguistici che provano a dirlo, a raccontarlo. Ed è proprio lo sfuggire quello che rimane. Non è un territorio quello che si vuole camminare in queste pagine, ma una zona di «deterritorializzazione» fuori dai confini tracciati, da quello che già conosciamo o crediamo di conoscere. Consapevoli che l’esplorazione geografica e una pratica che ha quasi esaurito gli spazi bianchi, mentre sul terreno dell’esplorazione temporale c’è ancora molto da lavorare.
L’Appennino assomiglia terribilmente a quei «fasmidi» di cui parla Didi-Huberman, insetti stecco in grado di assumere la forma o il colore dell’ambiente nel quale vivono, diventando in questo modo impossibili da reperire, annullando la differenza che abitualmente vediamo tra un essere animato e un ambiente spesso considerato, appunto, inanimato. L’Appennino è un phasma (fantasma) nel suo aderire perfettamente alla superficie, refrattario a oggettificarsi in qualcosa che si riesca veramente definire, quieto nel rimanere sempre inafferrabile. Al massimo un brillio nella rifrangenza della luce, che puoi scorgere lungo una strada che porta a un passo, o in un bosco, tra gli abeti, sul limitare della conca rugosa di un monte, e nelle storie che possiamo raccontare, nelle narrazioni possibili che diventano strumenti per pratiche immaginative comuni.
L’Appennino attraversa queste scritture eterogenee composte di racconti, saggi, dati biografici e narrazioni per farsi palinsesto mobile e alterità necessaria a ritrovarsi. Attraverso la mediazione dell’alterità ecologica di luoghi, piante e animali (ri)prendiamo la misura di un vivere che ci è sfuggito di mano e di un tempo che, frettolosi, abbiamo appianato a eterno presente. In ascolto, tra osservazione e rimemorazione, l’ecobiografia scrive (graphein) e narra l’interazione tra storie di vita (bios) e ambiente (oikos), mostrando i legami inscindibili tra noi stessi e il mondo.
Continuare a disegnare mappe, dunque, senza trasformarle in rotte di conquista, ma in rotte di dispersione, di «disambientamento», esplorare lo spazio bianco, le rotte fuori mano, salire in altitudine, svalicare, guardare giù questa terra che brucia, questo mare che ritorna. E soprattutto, mantenere salda la testa, il cui peso poggia sulla prima vertebra della colonna vertebrale, chiamata, ancora una volta, atlante.