Alberto Vanolo, docente di Geografia politica ed economica presso l’Università degli Studi di Torino, ne La città autistica (Einaudi 2024), riflette sul tema della condizione autistica in relazione agli spazi che abitiamo. Si interroga su quanto questo argomento possa essere, per la nostra società neuronormativa, stimolo per immaginare una realtà che consideri come abitanti persone che generalmente non sono pensate come parte attiva della comunità, persone che vengono di conseguenza invisibilizzate dalle scelte urbane ed economiche in relazione agli spazi pubblici. Mettendo in discussione il concetto di città europea standard basata sul modello coloniale, bianco, neurotipico, maschile, capitalista, Vanolo indaga come si possa invece pensare una città aperta alle persone autistiche e, più in generale, alle persone disabili. Quanto può spaventare la rivendicazione del diritto a vivere la città da parte di queste persone? Ma soprattutto, quanto può essere rivoluzionaria la presa di coscienza e la lotta al diritto per la propria esistenza da parte di chi non si pensava nemmeno esistesse?
Di spazi e movimenti parla anche Italo Calvino ne Le città invisibili, opera in cui descrive un meraviglioso viaggio attraverso centinaia di città diverse, ciascuna basata su caratteristiche mirabolanti e uniche. Sono città che il narratore della storia, Marco Polo, tenta di descrivere all’imperatore mongolo Kublai Kan, che quei territori li domina ma che mai li ha potuti vedere e che mai potrà osservarli di persona; sono città che «come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra».1
Guidate dalle parole di Calvino e dalla potenza visionaria delle sue città invisibili proviamo, in dialogo con Alberto Vanolo, a ipotizzare, invece, delle città che seppur strane e decentrate, possano essere viste.
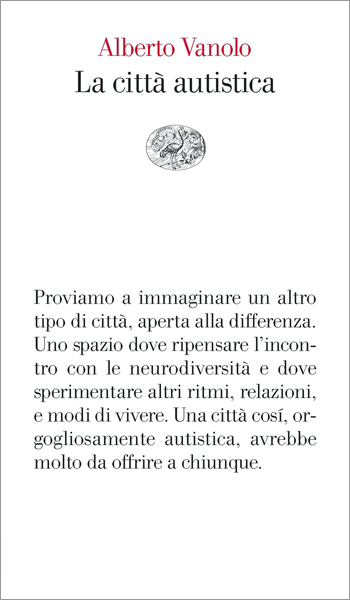
«A Melania, ogni volta che si entra nella piazza, ci si trova in mezzo a un dialogo. […] Si ritorna a Melania dopo anni e si ritrova lo stesso dialogo che continua. […] La popolazione di Melania si rinnova. […] Chi s’affaccia alla piazza in momenti successivi sente che d’atto in atto il dialogo cambia, anche se le vite degli abitanti di Melania sono troppo brevi per accorgersene».2
MF: Nel saggio lei sottolinea l’importanza della comunicazione affermando che «la questione del linguaggio non è marginale. Esso plasma le prospettive e modi di intendere le cose, oltre a creare uno spazio di identificazione, rivendicazione e trasformazione» (p. xviii).
Come si muove tra i tanti modi di esprimere l’autismo? Mi riferisco, per esempio, alla posizione dicotomica tra il termine strettamente politico neurodivergenza, derivante dall’apporto dei Disability Studies e dei Critical Autism Studies, e l’ambito medico che invece mantiene un’impostazione più tradizionale e patologizzante sulla disabilità mediante espressioni come disturbo o invalidità. Nel saggio i due poli sembrano sovrapporsi, scelta che trovo interessante, molto intersezionale. Mi piacerebbe sapere cosa l’ha spinta a integrarli in maniera così sinergica.
AV: La tensione fra la cultura biomedica, che chiaramente ha una posizione egemonica, e il paradigma della neurodiversità è una questione calda con posizioni differenti, anche all’interno dei movimenti e delle comunità che sviluppano discorsi sull’autismo. Penso non sia produttivo un rigetto categorico del sapere biomedico, sia per ragioni pratiche (l’immenso patrimonio di conoscenze e metodi che possono migliorare concretamente la vita delle persone) sia politiche, perché per molte persone il rifiuto di quel paradigma culturale è percepito come negazionismo o rifiuto della scienza, cosa che nessuna persona sensata auspica. In questa fase, ritengo sia utile combattere l’egemonia di quel modello stigmatizzante, ma al contempo cercare alleanze anche all’interno della cultura biomedica. Questa però è una visione personale e mi rendo conto che molte persone, più radicali o con un’esperienza drammatica di violenza culturale del modello biomedico, possano assumere una posizione più dura: nutro molto rispetto per loro. All’interno di questo quadro, la politica del linguaggio è uno strumento importante per combattere schemi culturali da abbattere e rivoluzionare. Pochi giorni fa ho scoperto per la prima volta il significato dell’acronimo CAD, termine utilizzato con riferimento a strutture territoriali molto comuni nel mondo della disabilità. In genere si usa semplicemente la sigla, senza sapere il significato delle varie iniziali: Centro Addestramento Disabili. C’è molta strada da percorrere.
«Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera di vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il modello di un’altra Fedora. Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse, per una ragione o per l’altra, diventata come oggi la vediamo».3
MF: Lei sostiene che: «Il modo in cui ci identifichiamo si sovrappone alla nostra vita urbana» (p. 54). I luoghi che abitiamo sono essenziali per la formazione della personalità. A proposito di spazi (non realizzati) lei definisce l’ipotetica città autistica quasi come una «città utopica» (p. xv). Ha senso, addentrandosi nell’ambito della letteratura fantascientifica, parlare di città autistica attraverso la categoria della distopia o addirittura dell’ucronia? Non a caso credo, nell’introduzione lei stesso scrive che questo libro è «[l]a storia di ciò che avrebbe potuto esistere, ma non esisterà mai, perlomeno in questa forma» (p. vii).
AV: Sono affascinato da questo stimolo; conosco poco la letteratura sull’ucronia, ma senza dubbio l’immaginare traiettorie differenti, il cosiddetto what if, è un espediente interessante per decentrare lo sguardo e produrre riflessioni e significato, e non a caso esistono vari lavori nel campo delle scienze sociali.
Parlare di traiettorie differenti implica interrogarsi sulle categorie del tempo e dello spazio, elementi del tutto inscindibili nella costruzione dei fenomeni sociali. In linea con una tradizione di studi urbani critici, utilizzo la parola utopia con riferimento alla capacità di immaginare realtà (città) differenti, passo indispensabile per trasformare l’esistente e imprimere una direzione evolutiva. Immaginare è un compito importante, soprattutto all’interno di un sistema culturale che ci spinge a pensare che il futuro sia già scritto come estrapolazione del presente: sembra impossibile immaginare città non capitalistiche e pare inevitabile che vivremo in città popolate da droni e auto senza pilota, per fare due esempi molto banali. Il progetto di città autistica vuole essere il tentativo di imprimere un’altra direzione al modo dominante in cui si intende lo spazio urbano.
«A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono e s’intersecano. […] Una mappa di Smeraldina dovrebbe comprendere, segnati in inchiostri di diverso colore, tutti quei tracciati, solidi e liquidi, palesi e nascosti».4
MF: Rimaniamo nel campo semantico della fantascienza. Lei cita la filosofa Donna Haraway riguardo alla diffrazione, un fenomeno che si verifica quando un’onda incontra un ostacolo e questa vi si sovrappone creando qualcosa di nuovo. Un po’ come l’autismo fa con la società che secondo lei «raccoglie una gran quantità di posizionamenti, discorsi, riflessioni che sfidano gli approcci convenzionali e il modo dominante di considerarlo come una patologia da rimuovere» (p. 20).
L’idea di innesto, di visioni nuove che nascono e decostruiscono l’ordine stabilito ha molto a che vedere con un altro concetto di Haraway: il corpo cyborg. In Manifesto cyborg Haraway afferma infatti che «[i] corpi sono diventati cyborg, organismi cibernetici, combinazioni/aggregazioni di corpi tecno-organici ibridi e testualità».5
Quanto secondo lei, una persona autistica con il proprio funzionamento neurodivergente può essere definito cyborg: una fantasmagorica creatura, mostruosa nella propria differenza, dissonante con la norma, voce del futuro? Ha senso per lei definire le varie menti autistiche “cervelli cyborg”?
AV: Siamo tutte e tutti cyborg! Uno degli insegnamenti di Haraway e della riflessione che ha preso forma successivamente è proprio l’importanza di ripensare in maniera radicale il modo in cui intendiamo e rappresentiamo i confini dei nostri corpi, delle menti, del sé o dell’identità. Siamo assemblaggi porosi, costruiti attraverso relazioni, accoppiamenti con tecnologie, discorsi, processi culturali di mille tipi. L’idea stessa di corpo “normale” può aver senso solamente in termini statistici. In più, il mio stesso corpo contiene elementi cyborg: il mio sorriso ha una certa forma perché ho indossato un dispositivo ortodontico per tutta l’adolescenza e cammino senza occhiali perché un piccolo intervento laser ha rimosso la mia miopia. Questo schema è applicabile anche nel campo neurologico o sociale: il modo in cui ragioniamo, apprendiamo e ci relazioniamo al mondo è definito da assemblaggi biologici e tecnologici (per esempio le tecnologie dell’apprendimento e della socializzazione) che trasformano il modo stesso in cui esistiamo, ci autorappresentiamo e siamo identificati o identificate come soggetti. La mente autistica, per come la vedo io, non presenta alcuna peculiarità rispetto alla dimensione cyborg.
«Una descrizione di Zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città non dice il suo passato, lo contiene […] scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, […] ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole».6
MF: Nel corso della lettura del suo libro ci si imbatte nei concetti di psico-geografia e passeggiata situazionista, temi trattati anche nel saggio La città femminista di Leslie Kern, in cui l’autrice parla di una città a formato di tradizione, norma figlia del passato, e di un’altra città, ipotetica, a portata – anche – di “fuori norma”. Kern afferma che esistono delle esigenze specifiche rivendicate da alcune persone socialmente emarginate che possono però essere estese a nuovi modi di vivere. Kern si focalizza sulla libertà di chiunque di essere flâneur, personaggio urbano che si aggira in libertà per lo spazio urbano. Lei e Teo durante le vostre passeggiate siete flâneurs, e in quanto persona autistica che si muove nello spazio lo sono anche io: rivendichiamo la libertà al movimento cittadino. Lei che vive a Torino e che quindi conosce bene la città, come la vede dal suo punto di vista di caregiver?
AV: La città è un ambiente complesso e differenziato: il modo in cui vivo la mia dimensione di caregiver (o curacari, riprendendo il titolo di un bel libro) è diverso rispetto ad altre persone, così come l’autismo che vivo quotidianamente ha caratteristiche peculiari. Vivo con gioia la dimensione urbana torinese, ma devo dire che sperimentiamo soprattutto piccole isole urbane, spazi pubblici e privati con i quali abbiamo sviluppato un legame, perché inevitabilmente la città è grande e solo alcune aree fanno parte dei nostri ritmi quotidiani. Ma siamo felici di trasformarci e immaginari flâneur che intraprendono spedizioni psico-geografiche in aree sconosciute: per noi è un gioco, ma certamente non può piacere a chiunque e non voglio suggerire che l’idea del flâneur o della flâneuse possa funzionare per chiunque.
MF: Quali azioni potrebbero rendere la nostra città più autistica?
AV: Una città autistica, perlomeno nel senso in cui ho declinato l’espressione, si costruisce sia attraverso la concreta materialità di servizi, progetti, interventi e welfare, sia attraverso una cultura della varietà, dell’eccentrico, dello stravolgimento delle norme, della fascinazione per l’alterità. Senza contare la centralità di un’accezione progressista della cura, lontana dal pietismo e dalla lettura più retorica dell’inclusione, termine che – in alcuni casi – sembra definire l’accettazione generosa da parte di un gruppo dominante e “normale”.
«In due modi si raggiunge Despina: per nave o per cammello. La città si presenta differente a chi viene da terra e a chi viene dal mare. […] Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone; e così il cammelliere e il marinaio vedono Despina, città di confine tra due deserti».7
MF: Lei insegna presso Unito. Le chiedo: e in Università? Così come la città, anche l’ambiente universitario – che ne è diramazione – ha la forma del potere. Forse però ci sono degli sguardi nuovi attraverso cui osservare le aule. Quali strumenti e quali barriere architettoniche potrebbero essere ripensate all’interno di questo ambiente?
AV: Nella mia sfera universitaria osservo nuove sensibilità e una progressiva apertura a modalità e percorsi di apprendimento atipici. Si parla di DSA, esistono collettivi di studenti disabili e/o neurodivergenti, ci si interroga sulla politica del linguaggio e su come costruire un’università più umana, meno performativa, più aperta e sostenibile. Il tutto, paradossalmente, mentre altre potenti spinte procedono in direzione contraria, con una cultura individualista e neoliberalista che si insinua ovunque, basti pensare al linguaggio dei crediti formativi e dei piani-carriera. Il risultato mi pare molto parziale e la strada da percorrere lunghissima.
MF: Nel saggio discute sulle difficoltà sensoriali di molte persone autistiche: quali potrebbero essere interventi idonei per raggiungere allievi e allieve autistiche nello specifico dell’ambito accademico?
AV: Al momento l’ufficio principale che si occupa di queste tematiche tende a riprodurre un approccio burocratico, come forse è giusto che sia, e le decisioni concrete su come gestire l’insegnamento o la verifica dell’apprendimento in uno scenario di neurovarietà (perché tutte le aule contengono necessariamente persone con meccanismi neurologici variegati) sono lasciate in capo a singoli o singole docenti. In molti casi si riscontra la volontà di mettersi in discussione e allontanarsi dai vecchi modelli di insegnamento che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, altre volte non accade e si riproducono approcci violenti e conservatori. La questione è urgente e il dibattitto dovrebbe assumere una dimensione collettiva e politica.
«Olinda non è certo la sola città a crescere in cerchi concentrici. […] Le vecchie mura si dilatano portandosi con sé i quartieri più antichi, ingranditi: […] un’Olinda tutta nuova che nelle sue dimensioni ridotte conserva i tratti […] della prima Olinda e di tutte le Olinde che sono spuntate una dall’altra; e dentro a questo cerchio più interno già spuntano […] l’Olinda ventura e quelle che cresceranno in seguito».8
MF: Vorrei concludere questa intervista con una riflessione che si trova in chiusa del suo libro e cioè l’idea che la città offra tantissime possibilità figlie del capitalismo, in particolare la corsa verso l’acquisto e accumulo delle novità e la totale mistificazione della collaborazione umana a discapito di un imperante individualismo. Come, in questa società, le persone autistiche, generalmente poco attratte da prodotti diversi da quelli che di solito usano e spesso richiedenti reti sociali forti, possono davvero sovvertire il sistema?
AV: Credo che una politica della neurodivergenza possa saldarsi e mescolarsi con altre battaglie consolidate, come quelle contro l’ingiustizia sociale, il razzismo, il patriarcato, l’eteronormatività, lo specismo e altre ancora. Il capitalismo, e in particolare la cultura del capitalismo e del neoliberalismo oggi dominante, forgia un sistema da ripensare e combattere. L’autismo, nel suo essere “radicalmente diverso” rispetto alla maggioranza delle menti neurotipiche, credo possa offrire interessanti punti di osservazione o di vantaggio in questa lotta culturale. Al contempo, poiché il capitalismo si appropria di tutto, anche il mondo dell’autismo si è popolato di servizi, prodotti, logiche performative, retoriche e possibilità di estrarre profitto. Si tratta di un discorso complesso e capisco le ragioni di chi ha criticato questo aspetto del mio libro, sottolineando la dimensione ideologica del mio discorso, apparentemente lontana dai “veri problemi delle persone autistiche”. Credo però solamente una visione critica molto ampia della politica dell’autismo possa dare visibilità a dimensioni sottili della stigmatizzazione e dell’ingiustizia.
Conclusione
Negli anni Sessanta scriveva Calvino che «d’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda» (Le città invisibili, cit., p. 42). Lo ribadisce oggi Vanolo durante l’intervista definendo la città come «la dimensione del vivere comune». Nello spazio che abitiamo cerchiamo, infatti, la possibilità di mostrare la nostra personalità, di conseguenza essa viene plasmata dai luoghi che percorriamo. Le città mostrano come la pensiamo e chi siamo come società, quali bisogni ci mobilitano. Una città autistica, forse utopica o forse ucronica nei suoi intenti, non potrebbe che ampliare il concetto che si ha di umano, allargare lo spetto di identità che per nascita possiedono il diritto, spesso però negato, di muoversi nel mondo come persone libere, agenti della propria voglia di scoprire, di fare, ma soprattutto di essere.
—
1) Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, 2015, p. 42.
2) Ibid., p. 78.
3) Ibid. p. 31.
4) Ibid., p. 87.
5) Donna J. Haraway, Manifesto cyborg, Feltrinelli, 2022, p. 148.
6) Italo Calvino, Le città invisibili, cit. pp. 10-11.
7) Ibid. p. 17.
8) Ibid., pp. 126-127.
—
Immagine di copertina:
mural del collettivo Orticanoodles dedicato alla consapevolezza sull’autismo, Hotel Astoria, Milano.





