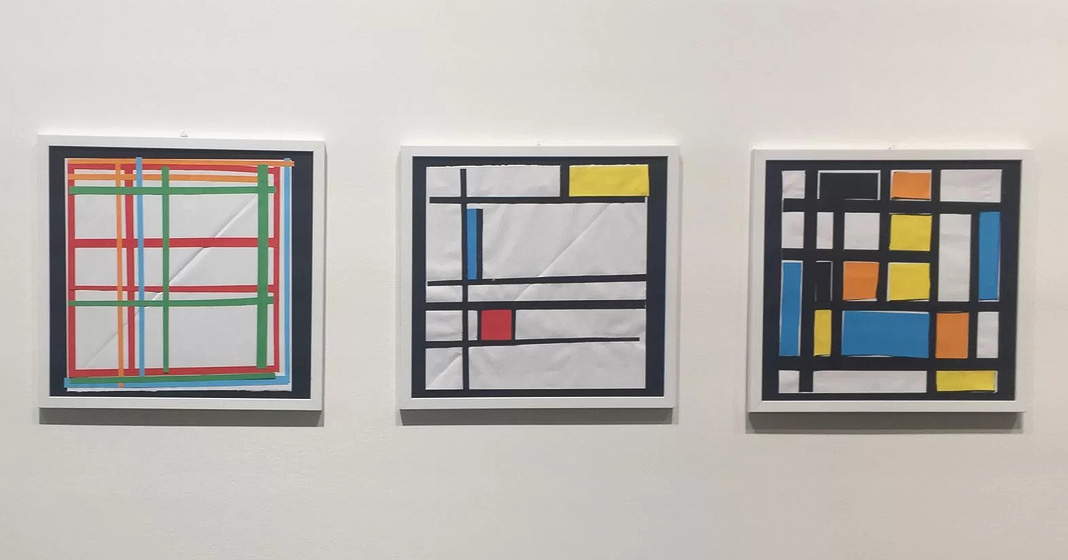Sono decenni ormai che le persone autistiche prendono parola, danno espressione alla loro relazione peculiare al mondo, all’orizzonte surdeterminato di non conformità relazionali, sensoriali, cognitive, esistentive che ne costituisce la singolarità. I nomi sono noti anche al di fuori della cerchia, della bolla, di quanti si occupino di autismo, la macellaia Temple Grandin, Donna Williams, John Elder Robison, Daniel Tamet, Dawn Prince (di cui è stato di recente tradotto il bellissimo Canti della Nazione Gorilla) e infiniti altri nel mondo, in Italia Fabrizio Acanfora, Claudio Ughetto, Alice Banfi, Luigi Lucantoni. Questa proliferazione di testi ha avuto il merito di aprire lo spazio per un discorso sull’autismo che si pone su un piano differente da quello medico, hanno creato una cultura dell’autismo, cresciuta inoltre in sinergia con le ricerche delle scienze sociali sulla condizione, i Critical Autism Studies, uno degli ambiti più vivaci dei Disability Studies contemporanei (in Italia segnalo Neurodivergente. Capire e coltivare la diversità dei cervelli di Eleonora Marocchini e l’ormai datato Tipi umani particolarmente strani. La sindrome di Asperger come oggetto culturale di Enrico Valtellina). Il passo ulteriore, per evitare che questa massa critica di pensiero rimanga strumento di crescita e consapevolizzazione limitato a chi si occupa di autismo, è che si cerchino modi per rompere la bolla degli autistici che se la raccontano (per quanto molto bene), per riuscire a incidere realmente sull’origine di molti dei problemi esperiti quotidianamente dagli autistici, ovvero la scarsissima tolleranza sociale alle non conformità, alla trasgressione dei codici della socievolezza, a modalità esistentive non previste. Parafrasando l’undicesima tesi, gli autistici finora si sono limitati a interpretare il mondo, ora si tratta di cambiarlo. Di reclamare la dimensione eminentemente politica del discorso sul non conforme.
Questa è l’intenzione del libro che vengo a presentare, Politiche dell’autismo. Etica, epistemologia, attivismo. Curato da tre giovani dottorandi, Alberto Bartoccini, Giulia Russo e Lorenzo Petrachi, il volume è nato da una call nominata La triade dell’autismo: Etica, epistemologia, attivismo. Dai materiali raccolti, molti e molto interessanti, è stato tratto un volume ulteriore pubblicato da LEM edizioni con lo stesso titolo, a cui ho partecipato.
La prefazione del volume edito da DeriveApprodi ne dichiara le intenzioni:
«Questo volume collettaneo, pensato a partire dal modello sociale della disabilità e scritto in ossequio al motto “nulla su di noi senza di noi”, riflette sui rapporti che l’autismo, come esperienza storicamente singolare e oggetto culturale, intrattiene con le pratiche diagnostiche e autodiagnostiche, le diseguaglianze di genere e le politiche neoliberiste, le rappresentazioni mediatiche e quelle storiografiche, rilanciando l’impazienza di trasformazioni sociali e culturali in vista di un mondo dove sia possibile, finalmente, «sviluppare la propria legittima stranezza» (p. 7).
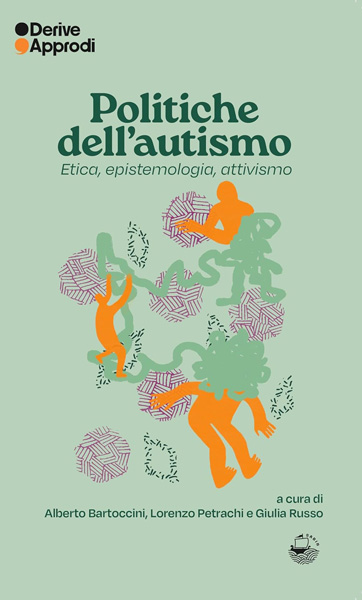
I saggi raccolti non sono organizzati secondo la tripartizione del sottotitolo; questa piuttosto è la matrice condivisa dagli autori, un ribaltamento virtuoso della triad of impairments in cui la pedopsichiatra inglese Lorna Wing inscriveva l’autismo. Vediamo brevemente cosa sostanzia il libro in una ricognizione sintetica delle singole proposte secondo la sequenza dell’indice, nell’intento di evidenziarne la ricchezza e l’articolazione.
Come primo contributo è stato scelto un articolo di Enrico Valtellina che tratta le dimensioni problematiche della diagnosi clinica, come classificazione, come evento nella vita di chi la riceve e come interpellazione. Per quanto abbastanza semplice, il testo si presta a introdurre una serie di questioni che verranno sviluppate più approfonditamente nel seguito del volume.
Più interessante il contributo di Alberto Bartoccini, Schiacciati dal mito di Gramsci. Note su attivismo e disabilità. Come fare attivismo, politico, sociale, quando la sensorialità e lo stress relazionale rendono difficoltoso, quando non autolesionista, esporsi sulla ribalta sociale? L’autore affronta con attenzione, arguzia e vivacità espressiva un tema fondamentale per l’attivismo autistico e non solo.
Caro Gervasi in Devirilizzare l’autismo. Contro l’extreme male brain theory, affronta uno dei pregiudizi che hanno affiancato l’autismo fin dalla sua nascita, e che ha trovato una canonizzazione in alcuni interventi dello psicologo inglese Sacha Baron-Cohen (cugino del più famoso Daniel), secondo cui l’autismo sarebbe correlato a un eccesso di testosterone, gli autistici sarebbero quindi super-maschi. Negli ultimi anni il discorso si è rivelato ciò che è, pregiudizio culturale.
Della rappresentazione mediatica dell’autismo tratta Angelica Mereu in Autismo nei media tradizionali e sui social: due racconti diversi e diversamente problematici, in cui raccoglie ed evidenzia i luoghi comuni, i pregiudizi, le connotazioni tragiche correlate al significante autismo che senza eccezioni vengono veicolati dai media, e le molteplici problematicità della proliferazione in ogni direzione del discorso sui social network.
Al libro ha contribuito anche un’autrice di spicco dei Critical Autism Studies, Majia Holmer Nadesan è autrice di Constructing Autism, testo del 2008 in cui rintraccia la genesi dell’autismo nella prima metà del ventesimo secolo in relazione ad alcune contingenze sociali e culturali. Autismo e singolarità del senso. Nuovi percorsi per i divenire della comunicazione, scritto con Viviana Lopez Torres, propone come forma di comunicazione la ricerca di modalità di interazione singolari, attente alle specificità dei soggetti coinvolti, al di fuori dei binari convenzionali previsti.
Esperienze di autodiagnosi tra epistemologia e politiche della cura di Giulia Russo affronta il tema interessantissimo e talvolta divisivo dell’autodiagnosi, per come si è data in relazione all’autismo. L’autodiagnosi sfida l’ordine del discorso medico, chi ha diritto di concederla per supposto sapere e ruolo sociale, ma a un tempo ne clona il sapere, senza peraltro inscrivere la diagnosi stessa nel patologico.
«L’individuo autodiagnosticato quindi si collocherebbe fuori dalle dicotomie sano-malato (o normale-patologico) proprio in quanto la sua esperienza troverebbe risposta nella patologizzazione del comportamento – o meglio, nell’iscrizione dell’atipia – all’interno di un paradigma che l’esperienza stessa dell’autodiagnosi sfida e rifiuta» (p. 101).
La ricchezza del volume sta anche nell’ampiezza dello spettro delle analisi proposte, ne è esempio Sulle tracce delle esperienze femminili autistiche nel Sud antico, dai riti dionisiaci all’internamento manicomiale di Francesca D’Egidio, che sposta dalla contemporaneità del discorso alla preistoria della condizione. Questa crescita di discorsi a margine, di contestualizzazione dello stesso in altri tempi e in luoghi specifici, ricorre in molte ricerche dei Critical Disability Studies, e non è esercizio accademico, ma talvolta aiuta a riconsiderare il presente, come nel caso di questo intervento.
Il titolo del libro risuona nel testo di Lorenzo Petrachi, 1875/2025 Affinità e neurodivergenze fra il compagno Marx e noi Note sul paradigma della neurodiversità e l’articolazione delle lotte. «Da ciascuna secondo le sue capacità, a ciascuna secondo i suoi bisogni. A ben vedere, il paradigma della neurodiversità non afferma nient’altro» (p. 124), esordisce Petrachi, sviluppando a seguire un’analisi del ruolo dell’autismo, degli autistici come soggetto collettivo paradossale, nell’articolazione delle lotte in sinergia e coevoluzione con ogni altra soggettività deprivata della possibilità concreta di assecondare i propri bisogni nelle contingenze del liberismo totalitario.
Altro contributo internazionale, questa volta di Silvia Maestre Liminana, Violenza epistemica nella rappresentazione dell’autismo. Il caso del programma televisivo Salvados, ricognizione degli stereotipi abilisti in un programma televisivo.
Autistica e female presenting nello spazio pubblico. Un’intersezione pericolosa di Giulia Gennaro è un racconto personale che ripercorre la violenza subita attraverso l’imposizione della norma di genere e comportamentale, la sistematica denegazione delle esigenze personali, sensoriali, emotive, per approssimare alla conformità.
Luca Negrogno, sociologo, da tempo ricerca sul contributo della cultura dell’autismo, delle elaborazioni teoriche degli Autism Studies e del movimento autoaffermativo correlato, in relazione alle pratiche dei movimenti antimanicomiali, in Premesse a un dialogo tra deistituzionalizzazione e neurodiversità, analizza come, pur da premesse teoriche distinte e talvolta difficilmente conciliabili, il movimento della “neurodiversità” e l’eredità anti istituzionale basagliana possano entrare in un dialogo produttivo. Come le politiche dell’autismo possano essere uno sprone per il rilancio delle politiche della deistituzionalizzazione.
Inclusione è un termine controverso, ma nel suo verso virtuoso si dà come possibilità di concedere accesso alle risorse culturali. In relazione all’autismo, il linguaggio può talvolta essere un vincolo. Renderlo accessibile, attraverso pratiche di riscrittura conformi alle necessità di fruizione, è un principio che sta ricevendo sempre più attenzione nel mondo. Il contributo di Andrea Dell’Antonio si focalizza su tale questione in Parliamone Chiaro. Etica comunicativa e linguaggio sull’autismo.
Le comunità autistiche: comunità di conoscenza rifiutata o alternativa? Equilibrismi epistemologici tra ingiustizia epistemica e postura simmetrica è la proposta di Eleonora Marocchini, testo molto articolato che evidenzia la pluralità delle prospettive delle comunità autistiche e di quelle scientifiche, le tensioni e le torsioni che costituiscono nel suo divenire l’oggetto culturale “autismo”.
“Attivismo” è uno dei termini della triade virtuosa individuata dal sottotitolo, e se è vero che anima in modo trasversale tutti i contributi, è preso specificamente a tema, e letto con le lenti del primo termine, “etica”, da Alessandro Monchietto e Alice Sodi in Desiderare con strategia. L’attivismo come esercizio di responsabilità.
Marialuisa Amodio è scrittrice e traduttrice, questo per anticipare la qualità del suo pezzo, senz’altro il più complicato da racchiudere in un abstract telegrafico come i precedenti, non ci provo, ma è tra i miei preferiti.
Chiude il volume Alice Scavarda con «Radicalmente differente?» Una storia culturale dell’autismo in Italia, ricognizione dell’emergenza dei discorsi e della loro riarticolazione alla luce del modello sociale e del paradigma della neurodiversità.
Ecco assolto quanto mi ero prefisso, questo compitino di riduzione in cinque righe di articoli molto intensi, articolati e complessi, non ha altra pretesa che quella di dare un’idea della varietà e della ricchezza dei temi proposti, e a un tempo della coerenza delle intenzioni, rimarcare la dimensione eminentemente politica della questione autismo.
Concludo con l’epilogo dell’introduzione.
«Politiche dell’autismo si presenta come il primo contributo collettivo sul tema volto a dar forma all’intreccio tra saperi situati, teorie ed esperienze politiche. Leggetelo passeggiando per strada mentre tutte vi guardano, fotografatene qualche pagina (ma non più del 15%…) e inviatelo al vostro collettivo, portatelo con voi all’appuntamento diagnostico per valutare il vostro psy supposto-sapere-(che-questo-libro-esiste). E se cerca di scoprire ancora una volta se avete una Teoria della Mente, ditegli che avete una Teoria TUPS, ricordategli che adesso è su carta stampata, pesa circa 400g ed è più comoda tra le vostre mani che fra i suoi denti» (p. 14).
—
Immagine di copertina:
Manuel Falcone, Manuel e Mondrian II, III e IV, 2016, collage su carta.