L’infanzia di Federica finisce in cucina, mentre un ago s’infila nella natica di Rosa, sua madre. Una donna del Sud che alla fine degli anni Cinquanta si trasferisce a Verona con qualche soldo e la licenza elementare.
Mentre l’infermiera del reparto prematuri le somministra la quotidiana iniezione per bloccare la produzione di latte, Rosa chiede notizie del suo secondogenito, partorito in una clinica privata e messo in una culla termostatica a qualche chilometro dal ventre materno.
Federica sente l’infermiera parlare di una crisetta avvenuta durante la notte. È questo l’appellativo con cui la donna definisce i danni cerebrali causati a suo fratello Francesco da una grave negligenza professionale.
In questo romanzo Federica Sgaggio dipinge il ritratto di una madre ferita, ma tenace. Una donna che la disperazione fa liquefare sul pavimento della cucina e che furia ed eleganza ricompongono, dentro a un cappotto nero di Courlande.
Tra queste pagine Rosa sembra abitare due corpi. Uno morbido di madre, avvolto dentro a vestaglie scolorite coi lacci cuciti a mano, e uno collettivo, protagonista delle battaglie femministe e di quelle per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.
Rosa vive in un corpo che muta con gli anni: tremante di febbre a un concerto di De André, clandestinamente innamorato di un amore osteggiato, strappato alla luna di Avellino per essere trapiantato al Nord, dove l’accento tradisce le origini e altri segreti. Un corpo tondo e caldo appollaiato fuori scuola in attesa della figlia – tenero ricordo d’infanzia – che sbiancando si svuota e poi muore.
Eppure, quello di Rosa è anche corpo politico: non si esaurisce nella dimensione autobiografica.
È un’intera generazione sopravvissuta ai bombardamenti, all’emigrazione, alla perdita di Dio, al miracolo economico del dopoguerra, alle manifestazioni e ai sogni infranti. È l’azzurro cavallo triestino che apre le porte ai reclusi e rende affare comune ciò che prima era disgrazia personale.
È un “noi” che sposta un poco più in là i suoi confini, contrattandoli: noi donne, noi terrone, noi mogli separate, noi madri e sorelle di figli con disabilità.
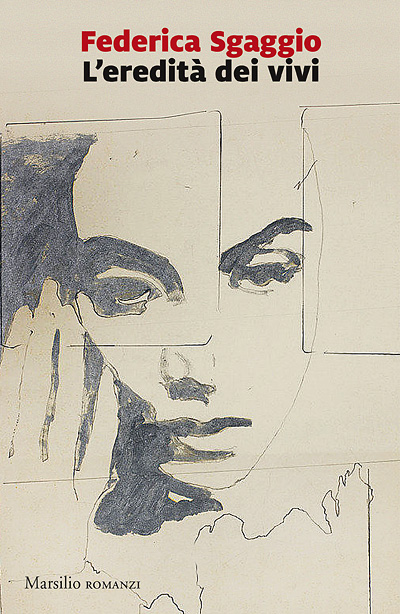
L’eredità dei vivi di Federica Sgaggio (Marsilio, 2020) racconta di salute e malattia senza fare sconti. Dà voce alla meraviglia di scoprirsi tuorlo nell’albume materno e alla fatica di farsi guscio che protegge i propri cari, quando si ha solo una manciata di anni.
Quando frequenta la prima elementare, Federica partecipa alle riunioni dell’Associazione italiana per l’assistenza agli spastici e alle assemblee delle Donne democratiche. Mangia a cucchiaini discorsi concitati sull’istituzione del SSN e sulla “scuola per tutti”. Impara che la politica è un modo per prendersi cura dei propri amori e, senza che le venga fatto alcuno sconto, si fa interlocutrice prediletta della madre. Quella donna del Sud che per le vicine di casa non possiede il senso della misura e sbraita ai bambini, sporgendosi dalla finestra della cucina: «Voi che quando passa mio figlio vi dividete come il mare al passaggio di Mosè!». Quella madre ritenuta pazza e snaturata, quando rifiuta di farsi anche fisioterapista del figlio, sottoponendolo a una pratica dolorosa che avrebbe forse potuto un giorno permettergli di camminare. La vipera che attacca velenosa i consolatori che bussano alla porta e parlano di suo figlio come di una prova di forza mandata da Dio. La roccaforte inespugnabile che si difende dalla pletora di medici e psicologi che le parlano di accettazione come resa.
Federica è figlia della furia e di un impiegato bancario con l’umore labile che, dopo la separazione dalla moglie, dorme per qualche tempo nella sua Alfetta. Della storia di quest’uomo, che le ha dato la vita, lei possiede soltanto qualche briciola: tra i ricordi più vividi, oltre a quelli legati alla sua morte, il piacere di sentirlo cantare per casa.
Quando i suoi si separano, nel 1979, Federica, Francesco e la madre vanno ad abitare in un appartamento infestato dalle blatte. Da quella casa, Federica se ne andrà nel 1993, per trasferirsi in una casa col pavimento in cotto e un piccolo giardino, adorno di camelie. Il congedo dalla madre è anche presa di distacco da Francesco e accesso a un’età adulta, questa volta in senso anagrafico.
Federica diventa compagna di Marco e madre di Giovanni. Lavora nella redazione di un giornale, con la speranza di poter cambiare qualcosa e rendere suo figlio fiero di lei. Scopre che anche il lavoro ammala: con le ingiustizie ha un contatto intimo sin da bambina, quando vede sua madre piangere per le parole di un’insegnante che definisce suo fratello “una bruttura” da piazzare fuori dalla classe.
In questo romanzo il lettore si affaccia dal bordo di una membrana sottilissima, che separa i sani – benestanti e composti, dai lottatori febbrili del “circolo della sfiga”. Entra in casa di Rosa insieme agli assistenti domiciliari che la aiutano con Francesco, prendendo in cambio il calore di un caffè e di una storia. Cammina lungo le corsie d’ospedale dove, con Rosa, muore una generazione, dove la membrana sottilissima si ispessisce, marcando la netta separazione tra il medico detentore del sapere e il gruppo di malati e familiari, che domandano troppo, pretendono, disturbano, ricordano di esistere.
Ci è data in consegna un’eredità gentile: «Fa’ cos’ bonn», «Fai cose buone».
Affermare il diritto di esistere dignitosamente, fuori dal perimetro di uno sguardo paternalistico e dai confini di un pensiero istituzionale, è una cosa buona, da fare con furia, determinazione e parole.
Da fare con le mani.




